Il Palazzo delle Poste di Gorizia vera gemma dell’architettura
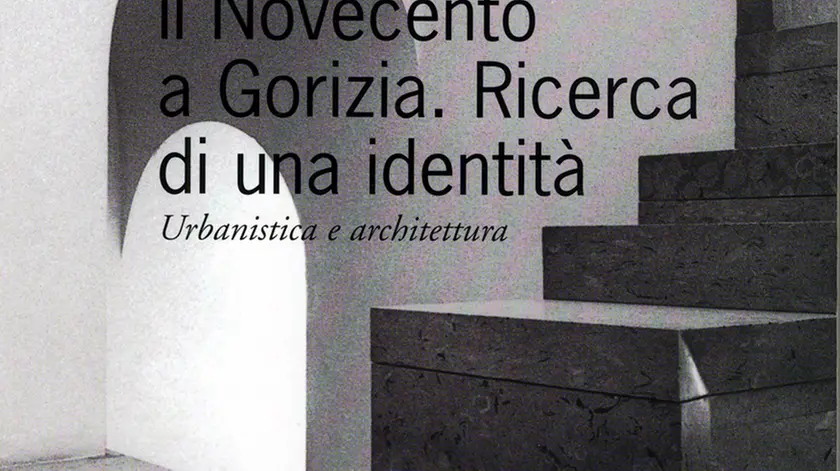
Il Palazzo delle Poste è senz’altro uno degli edifici più belli in città e non è un caso la scelta dell’avvincente scala in pietra del Vallone che conduce in alto nella torre per rappresentare nel 2000 “Il Novecento a Gorizia”, l’unica mostra fino ad oggi organizzata a tema dell’architettura moderna goriziana, grazie a Giulio Valentini allora assessore provinciale.
Nel catalogo della mostra, un bel saggio di Lorenzo Drascek e Kana Arioka racconta del palazzo realizzato per sostituire i vecchi uffici di via Garibaldi, nell’edificio dell’Hotel Posta oggi sede degli Uffici tecnici comunali. Dopo un primo progetto del 1924 per un palazzo in piazza Rotta, all’incirca la via Crispi odierna, ne viene approvato un secondo sul sito attuale, al posto del mercato coperto bombardato nel 1916 e poi demolito. Il progetto, al quale fu imposto che «avesse impostazione veneta e risolvesse degnamente l’angolo tra l’incrocio delle due strade, trovandosi in un punto di nuova centralità», fu approvato nel 1929 e ceduto nel 1930 il terreno dal Comune alle Ferrovie dello Stato, alle quali furono accorpate nel 1925 le Poste e Telegrafi, iniziarono i lavori del nuovo edificio inaugurato il 28 ottobre del 1932.
Progettista fu il bolognese Angiolo Mazzoni (1894-1979), che in qualità di ingegnere capo delle Ferrovie disegnò oltre 9 stazioni ferroviarie, tra le quali Bolzano, Reggio Emilia, Trento, Siena, Reggio Calabria e Roma Tiburtina e più di 18 edifici postali, tra cui Nuoro, Ferrara, Trento, Bergamo, Palermo, Pola, Pistoia, Varese e Roma Ostia.
Il Palazzo goriziano è «funzionalmente organizzato in due volumi distinti - uffici su corso Verdi e dopolavoro su via Oberdan -, collegati formalmente tra loro da un portico. Nel punto di unione svetta la torre (elemento simbolo delle piazze d’Italia volute dal fascismo) che funge sia da collegamento verticale, sia da elemento caratterizzante lo spazio pubblico, creato “retrocedendo” l’edificio sull’asse dell’angolo e dotandolo del porticato. Questo, svolgendosi sulle due facciate principali, prima cinge, piegandosi, il volume del dopolavoro, che ospita al piano terra il servizio al telegrafo con il mosaico di San Cristoforo, patrono dei postelegrafonici; poi nella zona d’ingresso è delimitato da possenti pilastri bugnati (che agli angoli ruotati di 45° scardinano la rigidità dell’impostazione planimetrica e denunciano gli ingressi) e, infine, è chiuso da trifore stilizzate nella sobria sala del pubblico alla corrispondenza e pacchi con i cordoli a cuscino, che inquadrano gli sportelli ed evidenziano la struttura in cemento armato».
Come in tutte le opere di Mazzoni, gli interventi artistici sono rilevanti. Oltre al mosaico di Matilde Festa Piacentini, i dipinti del goriziano Del Neri e del bolognese Tato, le sculture del ravennate Domenico Ponzi (tra le quali la statua del “Caduto” fusa in tempo di guerra per recuperarne il bronzo) e l’affresco del veneziano Guido Cadorin nella torre, e della “Famiglia italiana” una volta all'esterno sopra le buche d’impostazione, al quale è stato sovrapposto uno strato d'intonaco a imitazione dei mattoni ma che pare recuperabile, come è stata recuperata la funzionalità dell’orologio sulla torre le quali lancette hanno ripreso lodevolmente a girare dopo anni d’immobilità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








