L’incontro con un volume è come un mare da navigare per scoprire e capire
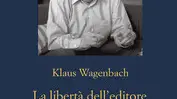
«Una vita è i suoi libri», scrive Massimo Recalcati, psicanalista, autore di alcune delle opere più profonde dei nostri tempi inquieti sull’essere padre e figlio, sull’arte, il tradimento, la scuola. Con un verbo e non con una congiunzione, per dire quanto profonda sia la relazione tra leggere e vivere. Il nuovo saggio ha per titolo “A libro aperto” (Feltrinelli, pagg. 185, euro 16,00). E racconta come “l’esperienza della lettura possa contribuire in modo decisivo nel dare forma singolare a una vita”. Un libro è “coltello” che “taglia”, “incide” l’esistenza del lettore; è “corpo” attivo con una dimensione erotica e non repertorio inerte di memorie; è “mare” da navigare per scoprire e capire. E così Recalcati, attraverso i suoi libri, l’“Odissea”, i Vangeli, “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern, “La nausea” di Sartre, “Essere e tempo” di Heidegger, “La strada” di Corman McCarthy e altri ancora, mostra come un libro “ci legge” e svela il lettore mettendone in chiaro i segreti e come la vita sia «una stampata», per riprendere una definizione di Jacques Lacan. Ben sapendo che «l’incontro con un libro è un incontro d’amore».
Di pagine è intessuta anche la vita di Albero Manguel, scrittore e soprattutto “lettore e amante dei libri”, che si racconta in “Vivere con i libri” (Einaudi, pagg. 128, euro 16,00). Il pretesto di partenza è il trasferimento da una grande casa di campagna nella Loira (con un granaio adatto ad ospitare una biblioteca di 35mila volumi) in un appartamento di Londra. Quale portare via, di tanti libri? E perché? Il trasloco diventa occasione d’una riflessione sulla lettura, la memoria, la formazione e la cura d’una biblioteca privata e poi pubblica, sull’amore per la conoscenza e sul piacere del racconto, sul valore delle parole consapevoli e la libertà e la responsabilità non tanto dello scrittore quanto soprattutto del lettore. Con un giudizio finale: le biblioteche pubbliche sono un indice essenziale della civiltà e della democrazia d’un paese.
Libertà è anche saper scrivere con proprietà e competenza. Come racconta Leonardo G. Luccone in “Questione di virgole”, riflessioni ironiche e sapide sul “punteggiare rapido e accorto” (Laterza, pagg. 244, euro 13,60). È essenziale, sapere usare bene, oltre che il congiuntivo, anche virgole e punti e virgole, punti fermi e due punti (ed essere molto parsimoniosi con i punti esclamativi, evitando fastidiosi eccessi di retorica). La punteggiatura corretta dà ritmo alla frase, precisa il senso del discorso, guida alla comprensione del testo, stimola il piacere del leggere: “Con una virgola ben messa si può illuminare una pagina”. Come muoversi, allora? Luccone usa gli esempi degli scrittori migliori e sa entrare nel cuore del linguaggio quotidiano. Mostrando, ancora una volta, che la sciatteria nello scrivere e nel parlare è un atto di colpevole inciviltà.
Libri e autonomia di pensiero e opere sono i cardini di “La libertà dell’editore” di Klaus Wagenbach (Sellerio, pagg. 184, euro 16,00) una raccolta di “memorie, discorsi, stoccate” d’un uomo cresciuto in una famiglia cattolica durante il nazismo, e poi, per tutta la vita, impegnato a dare buoni libri, che aggiungessero conoscenza e responsabilità al fluire della storia contemporanea, “per la partecipazione politica e la diffusione di idee nuove, di una letteratura nuova”.
Wagenbach ha molto amato l’Italia, infastidito dai luoghi comuni dei suoi connazionali sul nostro paese. E la sua lezione di lavoro e di vita è sempre attuale, sino alle ultime pagine, concluse nel 2010, un atto di fiducia nella carta ben scritta e stampata, nel marasma digitale dei cambiamenti hi tech: “Vuol mettere una cassetta di plastica in confronto a duemila anni di libro? Provi a pensare a come sarà tra cent’anni: il suo pronipote trova un libro in soffitta, con accanto un supporto digitale. Gli basta soffiar via la polvere dal libro, per poterlo leggere. La cassetta invece è danneggiata, il programma per leggere i dati che contiene non è più disponibile. Non c’è il disco rigido, e dov’è una presa elettrica? Insomma, da buttar via”. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








