È il terzo Carlo nella storia dei “principi” della chiesa goriziana
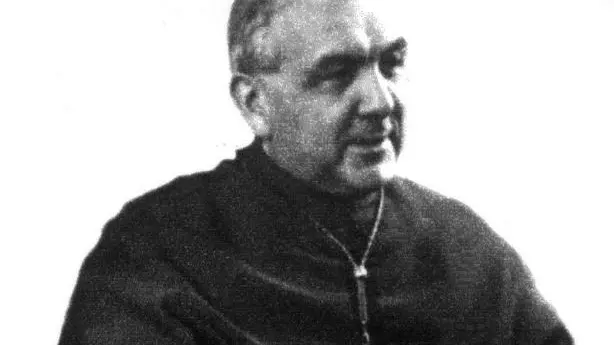
La serie degli arcivescovi goriziani raggiunge oggi il numero diciassette, con la nomina di mons. Carlo R. M. Redaelli alla cattedra di s. Ilario, partendo dal protoarcivescovo e principe del Sacro Romano Impero Carlo Michele d'Attems. Per la terza volta ritorna il nome di Carlo, dopo l'Attems e mons. Margotti, a ricordare un legame simbolico con la chiesa milanese, riconducibile a Carlo Borromeo, santo vescovo riformatore.
Nel corso del Novecento dopo il breve episcopato del goriziano Andrea Jordan, l'imperatore d'Austria, secondo la prassi allora vigente, nel 1906 nominò un altro sacerdote diocesano, mons. Francesco Borgia Sedej (1906-1931). La scelta fu poi confermata dalla Sede apostolica. Egli, sloveno di nascita, guidò la diocesi multilingue (slovena, italiana, friulana) con spirito imparziale ed un elevato senso di dedizione pastorale che gli guadagnarono la stima da parte delle varie componenti culturali. Definì il nazionalismo esagerato alla stregua d’un’eresia. Alla sua morte, dopo una lunga e per molti aspetti critica vacanza, papa Pio XI trasferì dalle rive del Bosforo a quelle dell'Isonzo, il primo presule tutto “italiano”, il romagnolo Carlo Margotti (1934-1951), delegato apostolico ad Istambul. Uomo dotato di intensa pietà, di una spiccata sensibilità liturgica nonché di uno spirito di carità riconosciutogli anche da parte avversaria, assistette al trionfo e al declino del regime fascista e alla conseguente fine della sovranità italiana su circa quattro quinti del territorio diocesano, assegnato alla Jugoslavia dopo la fine della seconda guerra mondiale. Nei diciassette anni di episcopato compì due visite pastorali (1935 e 1940) in preparazione al primo sinodo diocesano (1941), convocato per “adattare” la diocesi goriziana al panorama nazionale italiano, a spese dell'originalità impressale nei secoli dalla propria conformazione multilingue e multiculturale. In un certo senso questa “romanizzazione” forzata fallì, grazie alla cosciente resistenza dell'elemento sloveno, anche se il permanere della chiesa isontina nel nesso italiano si fece sentire col passare del tempo. Pur mantenendo lo status di sede metropolitana, la diocesi goriziana fu legata alla regione conciliare triveneta, l'area da cui provenne l'immediato successore di mons. Giacinto Giovanni Ambrosi, nativo di Trieste ma proveniente da Chioggia. Appartenente all'ordine dei frati minori cappuccini, fra' Giacinto con umiltà e discrezione curò il seminario con le vocazioni sacerdotali, la pietà eucaristica e mariana del popolo, promuovendo l'edificazione di nuove chiese e vigilando con occhio attento all'evoluzione della partecipazione dei cattolici alla vita politica ed amministrativa locale. Combattè il marxismo e favorì l'avvicinamento alla componente slovena in funzione anticomunista, nel quadro d'una presenza politica cattolica unitaria. Nel 1962 fu la volta di mons. Andrea Pangrazio, che fu particolarmente impegnato nella realizzazione della dottrina sociale della Chiesa e sensibile ai problemi legati al mondo del lavoro. Gli succedette colui che sino ad oggi è stato l'ultimo arcivescovo goriziano per nascita, mons. Pietro Cocolin (1967-1982), oriundo di Saciletto-Alture. Sulle sue spalle cadde l'incombenza dell'applicazione dei deliberati del concilio, che egli seppe attuare con delicata sensibilità verso l'ambiente locale, lontano da immobilismi o sprovveduti balzi in avanti. Tuttavia, le mutevoli temperie socio-culturali che segnarono i suoi quindici anni d'episcopato non gli risparmiarono amarezze e difficoltà, anche in ambito ecclesiastico. La vicinanza cronologica dei due ultimi episcopati, quello di p. Antonio Vitale Bommarco (1983-1999), frate conventuale chersino, e mons. Dino de' Antoni (1999-2012), anch'egli proveniente da Chioggia, impedisce un bilancio storico equanime e serio.
*storico dell’Arcidiocesi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








