La biblioteca ritrovata di Svevo resta a Trieste: acquistata e donata alla città
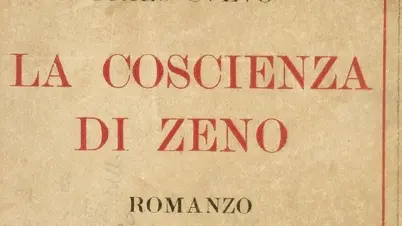
«Tagliarsi le unghie di sabato provoca malattie. Una collana di nocciole è ottimo rimedio contro le slogature. Per sapere se una malattia è mortale, metter un po’ di sale sulle mani del malato; se esso si scioglie buon augurio. Per guarire dall’orzaiolo, guardare nella boccetta dell’olio o strofinarsi l’occhio con un anello d’oro».
Sono passi dedicati alle credenze popolari in fatto di medicina (argomento che sempre appassiona Italo Svevo) di una pubblicazione intitolata “Alcune superstizioni del popolo triestino” che il romanziere riceve in dono nel 1891.
Ed è solo una delle curiosità e rarità bibliografiche provenienti dagli scaffali della casa di Svevo che da domani saranno esposte nella sala del Museo Sveviano in una mostra che ha diversi padri. Il primo è naturalmente il giovane Ettore Schmitz – prima e più che il romanziere Italo Svevo – che già nei verdi anni aveva preso l’abitudine di siglare a penna non solo le copie dei suoi libri, ma anche quelle dei giornali; un’abitudine grazie alla quale abbiamo potuto rintracciare due suoi bozzetti sconosciuti pubblicati nel 1883 su “L'inevitabile” di Teodoro Mayer (vedi l'articolo apparso su queste stesse pagine l'8 dicembre scorso).
Ma padri e madri di questa mostra sono anche Umberto Saba, per la cui libreria antiquaria sono transitati alcuni di questi documenti, Anita Pittoni, ideatrice e inascoltata promotrice di un Centro di Studi Triestini intitolato a Giani Stuparich (che, se fosse stato realizzato, sarebbe ora un vanto di questa città) e che a tale scopo aveva raccolto molti di questi libri e, infine, l'avvocato bibliofilo Cesare Pagnini che a sua volta ha collezionato questi tesori di cultura acquistandoli – per quanto è dato capire – un po' dall'uno e un po' dall'altra.
Non è finita: perché è certo fra i padri di questa mostra anche il libraio-ricercatore Simone Volpato che, dopo aver rintracciato qualche anno fa un primo nucleo della perduta – perché in gran parte distrutta dal bombardamento di villa Veneziani del febbraio del 1945 – biblioteca di Svevo nel mezzo di quella del genero Antonio Fonda Savio ha recentemente scovato nella biblioteca di Pagnini diversi volumi appartenuti a Carlo Michelstaedter e questo nuovo nucleo di testimonianze sveviane.
Infine – ma è un'ottima fine e, per il Museo Sveviano, un vero principio – padre di questa iniziativa è anche Lorenzo Pacorini alla cui sensibilità, oltre che alla generosità della sua InFin Spa, si deve che oggi questi inestimabili documenti (acquistati per una cifra che si aggira attorno ai 14mila euro) siano posti a disposizione degli studiosi e dei visitatori del museo.
Ma che cosa c'è, dunque, in questa raccolta di 33 libri e 12 fra giornali e locandine autografati (oltre a due faldoni di appunti pittoniani e una lettera inedita di Svevo ad Ario Tribel)? E perché il loro ritrovamento è salutato con tanto interesse? Bisogna ricordare che, proprio a causa della già ricordata distruzione della biblioteca di Svevo, ogni frammento di essa che viene alla luce offre nuove prospettive a una critica delle fonti sveviane che ha sempre dovuto far di necessità virtù ed esercitare in massimo grado l'intelligente congettura.
Tanto più quando, come in questo caso, il ritrovamento ci permette di gettar luce non tanto sulle letture del maturo e affermato romanziere Italo Svevo, ma su quelle del giovane aspirante giornalista e scrittore Ettore Schmitz detto Tajè che assieme ai fratelli Adolfo (Ado) ed Elio (Ejo) prendeva a modello i giornali per ragazzi della sua epoca (“El dindio”, “L'oca”, il “Babau. Spauracchio dei bimbi triestini”) e il già citato “L'inevitabile” - di cui prendono addirittura a prestito il motto, “Laboremus” - per confezionare lo scherzoso bollettino famigliare “Adotajejojade” (titolo davvero illeggibile che era composto dalla giustapposizione dei soprannomi dei tre fratelli Schmitz).
O quando ci consente di verificare le fonti con cui il giovane Ettore cercava di placare la sua mai esausta sete di scienza, leggendo i testi delle conferenze che si tenevano in città sui temi dell'origine della vita e del cosmo e dell'evoluzione umana (come quella di Carlo Ciatto su “La scienza, l’uomo e la scimia” e quella dell’avvocato Giovanni Scalzuni contro le teorie di Ernst Haeckel - quello de «l’ontogenesi ricapitola la filogenesi» - qui definito «apostolo del materialismo» e del darwinismo), ma anche caposaldi della ricerca scientifica dell'Ottocento come “La crèation et ses mystères dévoilées” di Antonio Snider-Pellegrini, l’opera in cui il geografo francese per primo promosse la teoria della deriva dei continenti.
Senza dimenticare nemmeno, visto che si parla di scienze, quelle “occulte”, allora di gran moda, di cui si dilettavano sia il poeta Filippo Zamboni, ricordato anche nella “Coscienza di Zeno”, di cui Svevo possedeva il curioso opuscolo “Il fonografo e le stelle e la visione del paradiso di Dante”, sia lo stesso Svevo, almeno a giudicare dalla locandina, anch'essa autografata, della tournèe del Cav. Scipione Karidis, che si autodefiniva «Celebre Negromante, Spiritista, divinatore del pensiero, Autoipnotista ed il più grande prestigiatore del secolo».
E, sempre fra le curiosità, non si possono non ricordare i due splendidi volumi di stampe giapponesi – ukiyo-e – che recano, oltre alla firma di “Ettore Schmitz” e alla data di acquisizione, il 1925, traccia di una loro precedente appartenenza alla biblioteca del Circolo Artistico Triestino e al pittore Carlo Wostry. Non mancano le opere filosofiche, con la traduzione italiana de “Il riso” di Bergson (che tuttavia è reso accessibile dal tagliacarte per meno di un terzo) e – poteva essere altrimenti? – quelle letterarie con la copia del “Panorama de la littérature italienne” di Benjamin Crémieux (che Svevo aveva recensito sulla pagine del “Popolo di Trieste”), i “Dieci raccontini” di Caterina Percoto e l'ostico poema espressionista “Das Nordlicht” del triestino Theodor Däubler che si affianca alle raccolte di Virgilo Giotti e dello stesso Saba.
Il quale ultimo ci regala, indirettamente, anche quello che forse è il pezzo più pregiato della raccolta, almeno dal punto di vista museale: la sua copia personale della “Coscienza di Zeno” sulla cui copertina, accanto alla firma e alla data ha aggiunto un entusiatico «Mio!», con tanto di punto esclamativo. Un frammento di storia della letteratura italiana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








