La riscossa di Thomas Bernhard
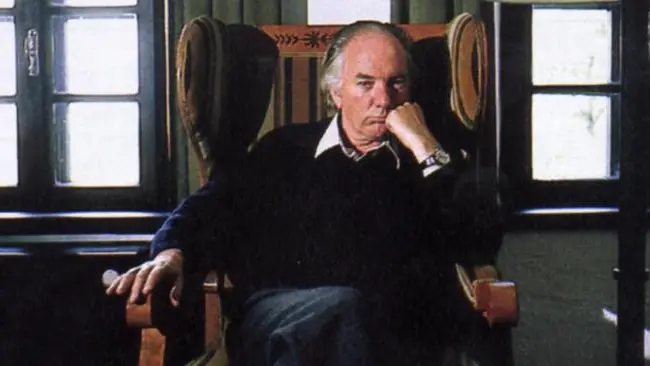
di LUIGI REITANI
Sarà perché invecchiando il buon vino acquista sapore, o forse perché la realtà è sempre più vicina alle grottesche e sferzanti rappresentazioni dei suoi libri; sarà per l’evoluzione del nostro stesso orizzonte estetico, per l’essere divenuto un modello imprescindibile per altri scrittori in tutto il mondo o per altre, imperscrutabili ragioni: sta di fatto che con i suoi personaggi maniacali, i suoi ossessivi monologhi e il suo virtuosismo musicale, a ventiquattro anni dalla morte Thomas Bernhard continua a guadagnare lettori e a riservare sorprese ai propri fedelissimi appassionati.
Così, mentre in Germania è giunta quasi al termine da Suhrkamp l’edizione completa delle opere in ventidue volumi, ed è imminente la pubblicazione del carteggio con l’amico e scrittore Gerhard Fritsch, dopo quella con l’editore Siegfried Unseld (per non parlare degli studi critici, delle rappresentazioni teatrali e persino di una piccola casa editrice interamente a lui dedicata), in Italia Rai Radio3 ha appena mandato in onda “Il Soccombente” letto da Elia Schilton, e sulle scene della passata stagione lo stesso romanzo ha visto come protagonista Roberto Herlitzka, che in tal modo ha sfidato Franco Branciaroli, regista e interprete del Teatrante. Inspiegabile, in questo perdurante e acceso interesse per lo scrittore austriaco, è solo il silenzio della casa editrice Einaudi, che da anni non ristampa due fra i maggiori romanzi di Bernhard: “La fornace” e “Correzione”, divenuti ricercatissimi oggetti sul mercato antiquario.
In compenso Adelphi ha affidato alla sicura mano di Elisabetta Dell’Anna Ciancia la traduzione di quattro brevi prose di Bernhard, raccolte con il titolo “Goethe muore”. Si tratta di scritti d’occasione, pubblicati tra il 1982 e il 1983 su riviste, cataloghi e programmi di sala, che però nulla hanno da invidiare per freschezza e inventiva alle opere maggiori dell’autore. Scorre in loro la grazia musicale del Bernhard maturo, pervenuto a questa nuova fase dopo la spietata resa dei conti dell’Autobiografia. E in lettore vi troverà temi, motivi e stilemi in lui caratteristici: il complesso delle origini, l’odio verso l’Austria, la ricerca della salvezza nel pensiero.
La prima prosa, che dà il titolo al volume (a dire il vero già apparsa in Italia in altre traduzioni su riviste e perfino messa in scena), deve la sua origine al duecentocinquantesimo anniversario della morte di Goethe, a cui Bernhard aveva anche dedicato la pièce Su tutte le vette è pace. A questo gigante della storia lo scrittore si rivolge con un irriverente sberleffo. Gli ultimi giorni della vita di Goethe sono raccontati dall’anonima prospettiva di un suo segretario, il quale a sua volta riporta – con un procedimento tipico di Bernhard – le parole di altre tre figure appartenenti all’entourage del poeta, preoccupatissime di tutelarne l’immagine pubblica e gelose le une delle altre, in una grottesca e spassosa rete di situazioni e intrighi. Non troppo velatamente Bernhard denuncia il processo di monumentalizzazione che si compie ai danni del genio creativo, nel momento in cui le sue parole sono filtrate, adattate e tramandate per interesse. Tuttavia, nel racconto Goethe stesso sembra riuscire a ribellarsi con successo all’apparato che lo circonda e addirittura a cacciare di casa il fedele Eckermann, l’autore di quelle celebri “Conversazioni” che ancora oggi determinano l’immagine del poeta del Faust.
In questo modo il Goethe in punto di morte di Bernhard finisce per somigliare non poco ai vecchi personaggi collerici dei suoi drammi e romanzi, impazienti verso coloro che li assistono, feroci verso il mondo, ossessionati da una qualche idea fissa. Con stupore leggiamo dunque che Goethe avrebbe affermato di essere l’«annientatore di quanto è tedesco!». Nella metamorfosi bernhardiana il principe dei poeti, pur consapevole del fatto che i suoi compatrioti lo venerano, ritiene infatti di essere «per loro pernicioso come nessun altro, e per secoli». E sebbene i suoi segretari cerchino affannosamente di dissuaderlo, Goethe insiste per incontrare al più presto il filosofo Ludwig Wittgestein, il cui Tractatus egli pone addirittura sopra lo stesso Faust. In tutta fretta uno di loro deve allora mettersi in viaggio per raggiungere in Inghilterra Wittgenstein, il quale però nel frattempo è morto di cancro.
L’anacronismo è evidente, essendo il filosofo austriaco vissuto nel Ventesimo secolo. Ma al di là del divertissement, Bernhard gioca in modo sottile con la memoria culturale. Il Goethe che riconosce se stesso in Wittgenstein è un Goethe spogliato di ogni monumentale certezza, individuato come fonte di una tradizione radicalmente diversa da quella canonizzata. È per questo che il racconto si chiude su un formidabile gioco di parole, purtroppo non ricostruibile in italiano. L’anonimo narratore riferisce, infatti, che le ultime parole dell’illustre poeta non sarebbero state, come si legge di solito nelle biografie e nelle storie della letteratura, le altisonanti Mehr Licht! («Più luce!») – interpretate pomposamente come estremo messaggio di fiducia nella ragione – ma piuttosto le nichilistiche o forse semplicemente troppo umane Mehr nicht! («più niente!»), insomma un gesto di rinuncia verso un’esistenza ormai divenuta insopportabile. I fedelissimi di Bernhard ricorderanno che lo stesso falso aneddoto ricorreva già nel volume L’imitatore di voci. La deformazione corrosiva della magniloquenza classica è del resto già implicita nel titolo tedesco del racconto (Goethe schtirbt), che sembra alludere all’accento francofortese di Goethe.
Se Goethe muore è un‘autentica gemma narrativa, le altre tre prose offrono un compendio essenziale di luoghi e situazioni bernhardiani. In “Montaigne” il protagonista trova un momentaneo rifugio dagli odiati genitori immergendosi nella lettura del filosofo francese (tra i molti riferimenti letterari di Bernhard già nell’Autobiografia) in una biblioteca di famiglia, posta romanticamente in una torre. In “Incontro” il narratore riconosce in una stazione un vecchio amico d’un tempo e inizia con lui un’unilaterale rievocazione delle atrocità subite da entrambi durante l’infanzia, dominata da una rigida educazione piccolo-borghese, il cui apice è costituito da grottesche ascensioni familiari in montagna. In Andata a fuoco. “Relazione di viaggio a un ex amico a bruciare in un sogno” è addirittura l’Austria, con tutti i suoi monumenti e istituzioni culturali.
Pungenti, amari e al tempo stesso giocosi, come solo il loro autore poteva permettersi, questi racconti mostrano, una volta di più, la grandezza dell’arte di Bernhard e la forza del suo approccio al nostro tempo e ai suoi falsi miti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








