L’antivita di Svevo scovata nella Trieste divisa dalla Storia
Nella biografia firmata da Maurizio Serra l’indagine sull’ambiente e l’epoca dello scrittore
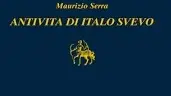
È stato fin troppe volte osservato come Ettore Schmitz non sarebbe mai diventato Italo Svevo se non fosse nato, cresciuto vissuto a Trieste. Solo una città come questa, così indefinita, divisa, contraddittoria, esposta al dolore della Storia e agli stridori della modernità, poteva fornire il terreno ideale per coltivare l’
antivita
, quella pulsione che deriva dall’insanabile «contrasto tra vita autentica e armatura esistenziale», motore primo della grande letteratura. Tutta la vita di Svevo non è stata altro che una continua lotta all’insegna di una granitica e a suo modo coerente antinomia esistenziale: ebreo ma convertito al cristianesimo, imprenditore soggetto alle ferree regole della professione ma scrittore votato all’anarchia d’artista, industriale di successo ma dalle aspirazioni socialiste, irredentista convinto ma in buoni affari con l’Impero, marito devoto ma assiduo frequentatore delle case di tolleranza, anima scissa sin dalla scelta dello pseudonimo, Svevo non avrebbe potuto esprimere al meglio la tragicommedia dell’esistere se non avesse coltivato proprio a Trieste il suo genio. Èd è questo il principale - ma non l’unico - punto di vista scelto da
Maurizio Serra
per raccontare l’
”Antivita di Italo Svevo” (pagg. 393, Euro 25,00)
, importante biografia dello scrittore triestino uscita a Parigi per Grasset nel 2013, poi in edizione spagnola ed ora pubblicata ampliata e aggiornata per le
Edizioni Aragno
. Diplomatico e scrittore, rappresentante permanente d’Italia all’Onu, già autore di premiate biografie come quella dedicata a Malaparte, Serra ha la capacità di fondere insieme lo sguardo acuto dello storico alla sensibilità del critico-letterato, in un approccio a più livelli interpretativi. A parte qualche sbavatura (per esempio l’errore di alcune date: il mese di nascita di Svevo, a pag.17, la data della “seconda redenzione”, dell’affondamento della corazzata Wien...), Serra indaga l’enigma-Svevo ad ampio raggio, calando la figura dello scrittore nella congerie triestina e internazionale di quell’epoca forsennata che è stata lo scollinamento tra Ottocento e Novecento, a cavallo tra due devastanti guerre mondiali, in anni in cui gli squilibri politici e sociali dell’Europa centrale portarono Trieste a pagare un prezzo altissimo a quello «sdoppiamento tra coscienza e realtà, che è carattere preminente della modernità».
Dalle origini familiari agli anni della formazione, dai rapporti con i grandi del suo tempo come Joyce, Saba, Bobi Bazlen, fino al matrimonio e alla quotidianità nella gabbia dorata di Villa Veneziani, per approdare infine al banale e fatale incidente stradale proprio nel momento in cui era arrivato il successo, Maurizio Serra passa al setaccio la biografia sveviana, cercando di mettere a fuoco meccanismi e ragioni che portarono Svevo a essere «universale nelle aspirazioni come nelle ambiguità, fino a nascondere nei suoi libri le proprie radici ebraiche e a ignorare il mondo slavo alle porte di Trieste».
L’esistenza di Svevo, nota Serra sin dall’introduzione, «coerente fino alla monotonia, è lambita da forze distruttive. Ettore Schmitz ha appreso a spese di Italo Svevo che l’unico modo di debellarle consiste nel non prenderle sul serio». È questa la cifra portante di Svevo, che esorcizza gli impulsi suicidi - tanto diffusi nella società del tempo - con «un’
aurea mediocritas
contro la modernità che gronda all’orizzonte». E quindi «nessun impegno politico né religioso, vaghe simpatie socialiste in gioventù, un risentimento sfumato contro i pregiudizi antisemiti che lo colpiscono solo di striscio». Ettore Schmitz - che rivendicherà sempre un’ascendenza tedesca, ma non austriaca - si forma in una città di fine Ottocento dove «una generazione di spiriti visionari, urbanisti, costruttori, decoratori, scenografi, entra in scena per cambiare l’aspetto di Trieste, renderla più aguzza, tagliente, eclettica, trasformarla in laboratorio d’avanguardia». Svevo però è alle prese con il fallimento economico del padre, Francesco, e con un impiego da “travet”, che lo strangola «in tutti i suoi propositi di scrittura». Inizia allora quello sdoppiamento arte-vita che «è un fenomeno diffuso nella Mitteleuropa percorsa dai venti della modernità», e che Svevo abita con un disagio tale da svelarsi persino nei dettagli. Come, ricorda Serra, l’abitudine di scrivere i testi letterari utilizzando il rosso dei nastri delle macchine da scrivere, «per non sciupare il nero destinato alla corrispondenza d’ufficio». Comportamento «bizzarro eppure perfettamente logico, perché non si tratta solo di economizzare ma di punirsi, di espiare un vizio, una malattia». Atteggiamenti che accompagneranno anche i rapporti con altri artisti, a cominciare da «el sior Zois», James Joyce, che a differenza di Svevo aveva ben chiaro «di avere di fronte a sé un grande destino: non un’antivita, ma una supervita». Era questa contrapposizione bipolare ad attrarre due scrittori, enormemente diversi, l’uno verso l’altro: a differenza di Joyce, Svevo è e rimarrà «fondamentalmente un realista che diffida dei miti, ignora le religioni, trascura le tecniche narrative d’avanguardia (...) è privo del dono di originalità verbale e lessicale, estraneo alla magia delle parole». Eppure il legame con Joyce, al pari di quello contraddittorio con Saba (i due finiranno per evitarsi incontrandosi per strada), sarà fondamentale per alimentare l’humus letterario dello scrittore - se non altro per indicargli quale strada
non
seguire. E Svevo da parte sua svolgerà «nondimeno un ruolo cospicuo nella maturazione di Jim come uomo e artista».
In quanto alle interazioni con la realtà sociale e politica del tempo, Serra si sofferma giustamente su quel periodo opaco, nella biografia sveviana, che va dagli anni della Grande guerra all’arrivo del fascismo. «La guerra e poi l’avvento del fascismo - nota Serra - portarono in piena luce la ferita identitaria di Trieste in tutta la gamma possibile e immaginabile delle manifestazioni di fobia, isteria, paranoia, schizofrenia. (...) Un’intera generazione composta di temperamenti sottili, complessi, ipersensibili si trovò esposta di colpo alla prova della guerra. Il disagio crebbe con l’insorgere, subito dopo, del modello virile fascista». È in questo inferno che maturerà il «secondo Svevo», come lo definisce Serra, quello, così succube della malattia del vivere, arrivato fino a noi ben in salute, se è vero che, oggi, «in un’epoca poco favorevole alla grande letteratura, Svevo sembra in ottima forma».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche
Video








