Letterario e non letterario, il confine si fa più labile. Anche il nuovo Museo dovrà fare scelte coraggiose
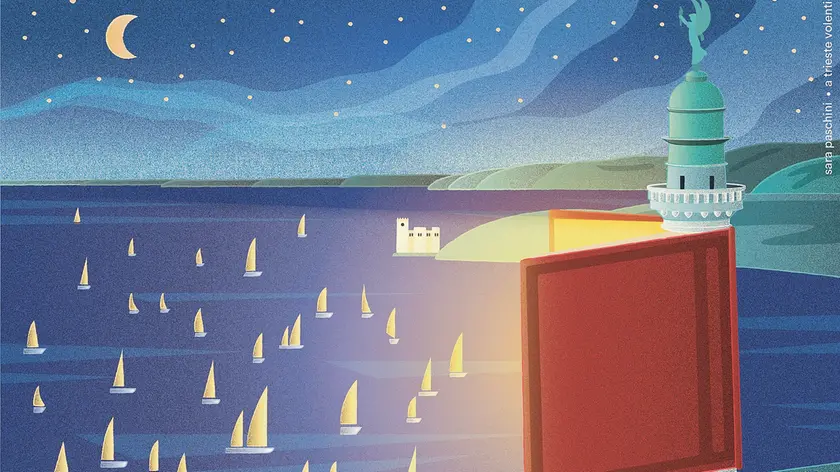
TRIESTE Che la letteratura triestina abbia caratteristiche di originalità rispetto ad altre è stato asserito a varie riprese, pur senza arrivare a una dimostrazione capace di mettere in gioco l'originalità del suo linguaggio. In quest'area battuta dalla bora si sono sperimentati infatti molti dei temi prodotti dalle crisi morali ed epistemologiche del Novecento, con la particolarità, questa sì in buona parte comune, che i racconti avevano sullo sfondo luoghi riconoscibili della città e dei suoi dintorni. Dunque, più che di letteratura triestina, si potrebbe parlare di ambientazione triestina per narrazioni anche molto diverse tra loro, che nell'insieme hanno tuttavia prodotto un'immagine forte del territorio.
Questa peculiarità ha determinato un esito interpretativo singolare, proprio a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando l'ideologia postmoderna ha consentito di accantonare il paradigma storico, dei "distinguo", per sostituirlo con uno geografico, che autorizzava ad appaiare autori di epoche diverse, e di tradizioni nazionali differenti, omologabili dal fatto di aver ambientato le loro opere nel medesimo contesto spaziale.
Oltre ai nativi venivano considerati triestini, infatti, anche scrittori che, pur avendo assai scarsa affinità tra loro, in questa città avevano preso dimora, per un periodo più o meno lungo, e l'avevano scelta come sfondo dei loro romanzi. Piuttosto che le caratteristiche letterarie, dunque, venivano messe in evidenza le tematiche messe in campo, anche in una prospettiva di "cultural studies". Il discorso interpretativo diventava così accessibile a un pubblico più vasto e trasmetteva contenuti riferiti a temi di larga generalità, ma ascritti allo stesso contesto, quello triestino: la psicoanalisi, la ricostruzione mnestica di una storia complessa, il viaggio, in tutte le sue accezioni, sono solo alcuni tra tanti. Inserita in un proficuo circuito turistico, Trieste ha continuato ad accumulare racconti, anche attraverso il linguaggio fonico- visivo messi in campo da televisione e cinema per produzioni di serial popolari, immagini pubblicitarie e, naturalmente, film. Divulgava vecchie ma anche nuove location, scorci paesaggistici e antropici accattivanti che portavano a rafforzare l'idea di una città letteraria.
Anche gli scrittori che qui si trovavano erano stimolati a cercare nuovi spazi dove collocare le loro storie: alcuni sono riusciti a "vedere" luoghi finora ignorati, come il vecchio campo profughi di migranti in fuga, o internazionalmente noti, come il Collegio del Mondo Unito. Altri hanno preferito percorrere itinerari lontani dai luoghi più scontati e dai caffè letterari, proponendo una città da visitare con lo zaino in spalla, con le sue osterie lontane dal centro storico, e le sue boscaglie di periferia, o il carso, divenuto palcoscenico di gialli inquietanti. Qualcuno ha fatto interagire il racconto letterario con la Trieste della ricerca scientifica.
Non pochi hanno capovolto con ironico scetticismo i cliché più consolidati, città della nevrosi o crocevia di identità plurime e di frontiere d'ogni tipo. Il turismo culturale, motore dell'economia nazionale, anche qui di stereotipi si alimenta, mentre i confini tra letterario e non letterario si stanno facendo sempre più labili. Per attrarre l'attenzione dei visitatori, il racconto della città deve venir inevitabilmente semplificato. E dilatato sfruttando adeguatamente il lato emotivo della conoscenza, capace di reagire a stimoli visivi ed auditivi e di assimilare così con maggior immediatezza informazioni ed immagini.
Anche su questi dispositivi sarà probabilmente impostato il costituendo museo della cosiddetta letteratura triestina, che dalla complessità e dalla diversità valoriale dei suoi esiti narrativi dovrà argomentare ridotte e dunque coraggiose scelte culturali ed estetiche.—
© RIPRODUZIONE RISERVA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








