Vecchie e nuove mappe per navigare nei mari agitati della crisi e della modernità
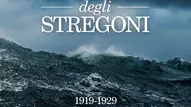
Vecchie e nuove mappe per cercare di navigare nei mari agitati della crisi. “Il disagio della civiltà”, aveva scritto nel 1930 Sigmund Freud, mettendo i contemporanei di fronte alle contraddizioni d’un tempo di radicali cambiamenti: una modernità carica di ombre. “Il disagio della postmodernità” è il titolo di una delle più importanti opere di Zygmunt Bauman, scritta nel 1997 e adesso in libreria in Italia per Laterza (pagg. 342, euro 18,00). In quasi un secolo molto è cambiato nella faticosa costruzione dei rapporti tra persone e società, ma rimane sempre acuto quel “disagio” che accomuna le due opere: la consapevolezza del conflitto tra pulsioni umane e regole, libertà e vincoli, ricerca della bellezza e del piacere e tendenze distruttive dell’individualismo.
Spiega Bauman, parlando di morale e giustizia, cultura come “cooperativa di consumatori”, verità della scienza e dell’arte, religione, comunitarismo e libertà: “Il tipico disagio della modernità derivava dal fatto di dover pagare la sicurezza restringendo la sfera della libertà personale e quindi dal non poter impostare la vita sulla ricerca della felicità. Il disagio della postmodernità deriva invece da una ricerca del piacere talmente disinibita che è impossibile conciliarla con quel minimo di sicurezza che l’individuo libero tenderebbe a richiedere”. La strada per la felicità è sempre accidentata. La crisi cambia segno, resta il dolore.
Su temi analoghi si confronta Christopher Lasch, uno dei maggiori storici delle idee del Novecento, in “L’io minimo” ovvero “sopravvivenza psichica in tempi difficili” (Neri Pozza, pagg. 288, euro 18,00), un libro del 1984 ancora più importante del suo predecessore di successo, “La cultura del narcisismo” e ora pubblicato in Italia da Neri Pozza. L’io sovrano ha visto ridursi gli spazi dell’egoismo cedendo a un “io minimo” che paga lo sradicamento progressivo e la fine delle speranze “di un’azione politica capace di rendere via via più umana la società industriale” segnata da crescita dei consumi ma anche delle diseguaglianze. Nell’analisi, venata di pessimismo ma per molti versi profetica (Lasch affronta più di trent’anni fa questioni diventate oggi di tagliente attualità), si contrappongono “poteri globali” e “mente globale” a persone ridotte ai margini. E si commenta: l’identità dell’individuo è un lusso, perché “l’identità implica radici, una storia personale, amici, una famiglia, il senso d’appartenenza a un luogo”. Viviamo dunque “sradicamenti”. Se ne esce? Con un nuovo senso di comunità, dato che “né Narciso né Prometeo ci guideranno fuori dalla condizione in cui ci troviamo”.
Con questa crisi fa i conti pure Massimo Recalcati, psicanalista autorevole, in “I tabù del mondo” (Einaudi, pagg. 150, euro 18,00). Il narcisismo e l’individualismo sfrenato hanno rotto regole, confini e limiti. La trasgressione non implica alcun sentimento di violazione. Ma non viviamo comunque vite felici. Occorre allora ripensare criticamente i tabù e le figure del mito e della letteratura (Ulisse, Antigone, Edipo, Medea, Caino, Isacco, Amleto, Don Giovanni) e ridare valore a parole forti, come preghiera, lavoro, desiderio, giustizia, famiglia, riscrivendo un’etica dei comportamenti personali e sociali.
Utile, in questo percorso, rileggere anche le pagine dei maggiori filosofi del Novecento, come fa Wolfram Eilenberger, uno dei maggiori filosofi europei, in “Il tempo degli stregoni-1919-1929, le vite straordinarie di quattro filosofi e l’ultima rivoluzione del pensiero” (Feltrinelli, pagg. 432, euro 25,00). Si parla di Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Walter Benjamin ed Ernst Cassirer, figure molto diverse tra loro e con strutture di pensiero anche radicalmente divergenti, ma accomunate dal bisogno forte di capire quanto, nella crisi di quegli anni, tra la fine della Prima guerra mondiale e le avvisaglie di nuovi disastri, potesse essere costruito tra riflessione sulla filosofia del passato e analisi critica della modernità. La metafisica si impasta con le riflessioni sulla vita quotidiana. E si cerca di costruire un nuovo pensiero. L’eco risuona ancora oggi.
Riproduzione riservata © Il Piccolo








