Boris Pahor: «Questo è il libro di mia moglie Rada»
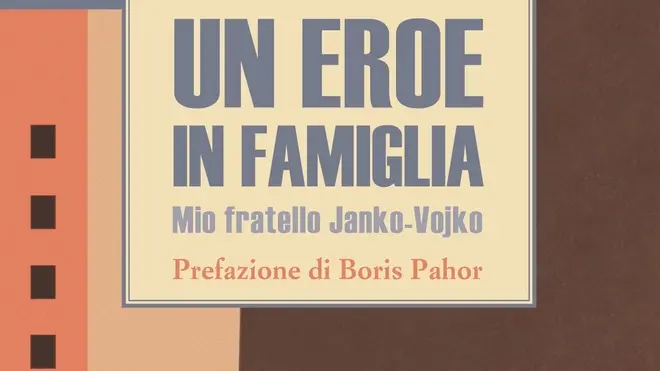
Da “Un eroe in famiglia. Mio fratello Janko-Vojko” di Radoslava Premrl, tradotto da Martina Clerici, pubblichiamo la prefazione di Boris Pahor per gentile concessione della casa editrice Nuovadimensione.
di BORIS PAHOR
È tutt’altro che semplice scrivere un’introduzione al libro della propria moglie o compagna, come si dice ora cercando di mitigare il termine tradizionale. Perciò cercherò di facilitarmi un po’ il compito, evitando fin da subito manifestazioni di elogio alla sua scrittura e concentrandomi principalmente sulla sua persona e sul suo carattere che peraltro in questo suo diario emergono appieno.
Radoslava (conosciuta anche con il diminutivo Rada) era una donna di carattere. Tra i fattori che hanno cementato il nostro reciproco interesse, un ruolo di primaria importanza va assegnato alla sua storia personale e alla sua esperienza di vita. Rada, tanto bella quanto brillante, non perdeva occasione di ribattere a una battuta, sia che vi si trovasse in disaccordo o, viceversa, fosse fin troppo in sintonia con un suo giudizio.
Così, quando affermai che il mondo postbellico avrebbe avuto molto bisogno di tante persone dai modi gioviali e schietti come i suoi, lei sbottò: «Come se io non avessi visto la nostra casa incendiata, come se non fossi stata in prigione e non mi avessero mandata al confino!». Già, il passato tormentato non era una mia prerogativa: se io ho assistito al rogo del Narodni dom a Trieste e sono finito in carcere per infine approdare nei lager, lei ha conosciuto in modo diverso, ma non meno traumatico, le brutalità dei totalitarismi del secolo scorso. Ci accomunava quindi anche un passato doloroso.
Venne il momento in cui sentimmo l’esigenza di far sentire la nostra voce, così misi in cantiere il progetto di pubblicare, con il supporto degli amici e di eventuali sponsor, una rivista politico-letteraria di orientamento democratico che intitolammo Zaliv (Il Golfo). Proposi a Rada di collaborare raccontando la vita di suo fratello Janko, noto con il nome di battaglia Vojko, caduto da partigiano e proclamato eroe nazionale sloveno. Rada esitò a lungo, perché restia a ripercorrere il suo passato: avrebbe infatti significato riacutizzare un dolore che il tempo aveva parzialmente attutito. Era troppo penoso rivivere l’atmosfera umiliante del genocidio culturale protrattosi per un quarto di secolo. E tanto più angoscioso, si capisce, era ridestare l’immenso dolore per la morte del fratello con tutti i suoi presupposti e le sue conseguenze.
Già, tutta la famiglia Premrl pagò a carissimo prezzo l’eroismo di Janko. Tuttavia, quando Rada si avvide che senza il suo contributo la rivista non si sarebbe realizzata, mi appoggiò in tutti i sensi: si occupò del lato pratico-organizzativo e, insieme, accolse il mio invito a far conoscere la storia di Janko-Vojko, che fu pubblicata appunto su “Zaliv” suddivisa in episodi nell’arco di qualche anno. Va detto che la rivista, nata come quadrimestrale, finì per trasformarsi in semestrale per una prosaica questione pecuniaria: all’infuori di una modesta sovvenzione della Regione Friuli Venezia Giulia, la rivista non riceveva alcun sussidio; la Slovenia, infatti, che all’epoca era una delle repubbliche federate nella ex-Jugoslavia, erogava contributi solo alle istituzioni chiaramente schierate a sinistra.
Ad ogni modo, le singole puntate di questa sua testimonianza vennero bene accolte ed ebbero un gran seguito di lettori, anche importanti come Edvard Kocbek, Alojz Rebula e altri al di qua e al di là della frontiera, cosicché ci pervenne la richiesta di raccogliere la storia in un unico volume. Ma Rada fu di nuovo recalcitrante, non c’era verso di convincerla.
Sulle prime non insistei più di tanto, perché avevo compreso che la sua ritrosia non riguardava soltanto il dover rivedere il testo che l’avrebbe proiettata, un’altra volta ancora, in quel suo vissuto. Considerata l’indole fiera di lei, del fratello e, in fondo, dell’intera famiglia Premrl, ciò che la feriva più nel profondo era dover esporre pubblicamente l’umiliazione che tutti loro avevano subita. Senza contare che le tormentate vicende del fascismo e della Seconda guerra mondiale – nello specifico per quanto riguarda il confine orientale italiano – venivano volutamente sottaciute, per motivi diversi, sia in Italia sia in Jugoslavia. Entrambi gli Stati hanno posto in essere provvedimenti ingiusti, tesi a far emergere solo parziali verità, peraltro soggette a vicendevoli strumentalizzazioni di comodo. In questa storia, sincera e genuina dalla prima all’ultima parola, Radoslava smaschera invece le brutture della guerra e di certa umanità senza fare sconti a nessuno. E dimostra, anche nelle vicende della sua pubblicazione, che quella dirittura morale, quella coerenza di principi e quegli stessi sani principi che andrebbero premiati, sono stati al contrario troppo spesso denigrati.
Dal canto mio ero però convinto che di quel male bisognasse comunque parlare, così mi rivolsi all’amico scrittore Drago Jan›ar. Lo pregai di telefonare a Rada, senza però fare il mio nome, per tentare di persuaderla a cambiare idea. In seguito Rada stessa mi rivelò che Jan›ar era andato dritto al sodo senza tanti preamboli. Le comunicò l’intenzione di inserire il libro nella lista delle pubblicazioni per l’anno seguente, bastava solo che Rada non opponesse un rifiuto. E lei non si oppose. Il volume fu pubblicato nel 1992 dalla Slovenska matica, istituzione scientifico-culturale di prim’ordine, di cui Jan›ar stesso era ed è il principale responsabile per la sezione letteraria.
Quel libro meritava una traduzione, ma per anni Rada si disse contraria senza alcuna esitazione. Ci volle l’intervento da Parigi di Evgen Bavcar, lo stesso che in passato si è adoperato perché andasse in porto la pubblicazione in francese del mio “Necropoli”: fu questa prima tappa a segnarne la successiva fortuna. Ebbene, quando Bavcar tornò alla carica con uno sponsor per la traduzione, Rada non disse né sì né no: conoscendola, era una sorta di approvazione, un tacito consenso.
Proprio allora, purtroppo, la valvola mitrale sostitutiva, che per dodici anni aveva fatto il proprio dovere, cominciò a dar segni di cedimento: in due mesi Rada fu ricoverata ben tre volte. Il terzo ricovero, che per lei fu anche l’ultimo, avvenne nel Sanatorio Triestino, in un ambiente più raccolto. Cercavo di scacciare l’idea che l’avrei persa e del libro non parlammo più né io né lei, finché una bella mattina mi misi alla macchina da scrivere e buttai giù una delega che mi autorizzava a rappresentarla presso un editore. E in un momento in cui entrambi eravamo ben disposti, le dissi semplicemente che, per portare avanti il progetto, mi serviva il suo consenso scritto. Sorridendo mi disse: «Ah, ecco, è per questo che sei venuto!». Ricambiando il sorriso controbattei: «Ritira queste parole, lo sai bene che ti vengo a trovare due volte al giorno». Allora lei, sfoderando per l’ennesima volta il suo senso pratico: «Su, dammi gli occhiali». E così, seduta sul letto, col foglio posato su di un libro che avevo a portata di mano, firmò e commentò: «Quel qualcosa che frutterà, se frutterà, destinalo ai nostri due nipoti. Non fare come al tuo solito che ti fidi di chi ti spedisce qualche conto corrente chiedendo di sostenere chissà che ricerche e invece pensa in primo luogo a se stesso».
Questa era Radoslava, un’ottima organizzatrice che non si perdeva in chiacchiere. Ma questa volta, nella sua ruvidità, lessi anche il dispiacere di doversi congedare per sempre dalla vita che tanto amava. Già, nonostante i suoi ottantasette anni, Rada era ancora entusiasta della vita. Io la vedevo ogni giorno, me ne stavo lì a guardarla, infuriato di non poter far nulla per trattenerla con me e consapevole che lasciare un libro a conferma d’essere esistita era un’infima consolazione.
Ma vorrei concludere questa nota con alcune righe un po’ più liete. La professoressa Marija Žagar, ottima insegnante di lettere slovene e nostra comune amica, quando lesse il presente libro mi inviò una lettera, aggiungendovi un biglietto indirizzato a Rada. Le scriveva così: «Rada, è un vero peccato che tu sia vissuta nell’ombra di Boris». È una lode che Rada certo meritava. Io credo però che non abbia scritto altri libri perché questo suo basta e avanza per raccontare gli orrori del XX secolo. Perciò preferì dedicarsi alla traduzione collaborando con la redazione Rai che tuttora cura le trasmissioni radiofoniche in lingua slovena. Inoltre le piaceva la letteratura per l’infanzia, tra i suoi testi preferiti c’erano quelli di Rodari: io ho scoperto tardi questa sua passione, comunque in tempo per dilettarmi insieme a lei e godere di momenti spensierati che ci facevano tornare fanciulli. E durante i suoi ultimi giorni in sanatorio, in un altro momento di serenità, le chiesi affettuosamente: «Radonci – così la chiamavano i nostri figli quand’erano piccoli – chi è che ti vuol bene?». E lei, pronta, rispose a modo suo: «Quando te ne sei accorto?». Allora feci un gesto con la mano come per dire «Hai voglia, da parecchio!» e aggiunsi: «A questo punto un bacetto ci starebbe proprio bene!». E questo è stato il nostro congedo.
Riproduzione riservata © Il Piccolo








