Alberto Bergamini l’uomo che inventò la terza pagina nei giornali italiani
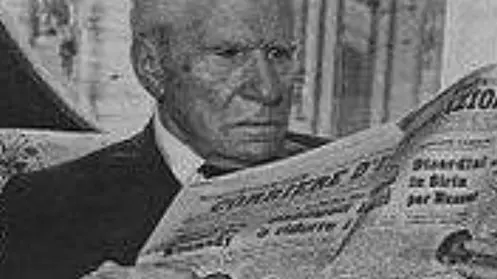
roberto curci
«Un’oasi fra l’arida politica e la cronaca nera». Così definiva la terza pagina dei giornali quotidiani colui che l’aveva appena inventata, nel novembre del 1901. Ma Alberto Bergamini, direttore del neonato “Giornale d’Italia”, non inventò soltanto la pagina che – da allora e per molti decenni – sarebbe stata il sancta santorum della cultura e dell’intellettualità del Belpaese: fu l’”inventore del giornalismo moderno”, come suona il sottotitolo del libro di Giancarlo Tartaglia, “Il giornale è il mio amore” (Edizioni All Around, pagg. 256, euro 15,00), biografia minuziosa ed empatica di un sanguigno emiliano di San Giovanni in Persiceto che al giornalismo (e alla politica) dedicò con coraggio e caparbietà l’intera esistenza (1871-1962).
Far nascere un nuovo giornale nella Roma del “Messaggero” e della “Tribuna”, sia pure sotto l’ala protettiva e simbiotica di un personaggio di spicco quale Sidney Sonnino, fu un’impresa fortemente voluta da un uomo che fin dagli esordi professionali – scrive Tartaglia – aveva “la smania di inseguire la notizia”. Farlo crescere fino a una tiratura di centomila copie (che talora sarebbero diventate 200 mila, e perfino 300 mila) fu la conferma di una vocazione eccezionale e totalizzante.
contatto con i lettori
Quel che a Bergamini premeva era il contatto costante e assiduo con i lettori affamati di un’informazione autentica e non ingessata. Offriva loro notizie spesso di primissima mano e pure i loro “dietro le quinte”, talvolta degli “scoop” veri e propri. Voleva che il giornale, letto al mattino, fosse come un “fresco e croccante panino”. Introdusse l’uso dell’illustrazione, della caricatura, della fotografia, delle interviste, dei referendum con cui interpellava i lettori, coinvolgendoli, sui più svariati argomenti. Inseguì “la gente” con edizioni speciali a raffica, fino a sette in un solo giorno. E a un certo punto s’inventò pure un’edizione speciale del primo pomeriggio, che curiosamente intitolò “Il Piccolo”.
Ma la sua intuizione vincente e destinata a lunga vita fu quella della terza pagina. Scrivervi e vedere la propria firma magari in calce all’articolo di apertura, l’elzeviro, sarebbe divenuta, nei decenni e in tutti i quotidiani italiani, l’aspirazione e l’ambizione di letterati, filosofi, artisti, scienziati. Essere un collaboratore fisso della “terza” di un importante giornale nazionale si sarebbe tramutato in un onore e un vanto, la conferma di appartenere alla “crema” dell’intellettualità. E pochi uomini di cultura si sottrassero a questa opportunità, o la snobbarono. Tant’è vero che sullo stesso “Giornale d’Italia” scrissero personaggi quali Pirandello, Fogazzaro, De Roberto, Panzini, D’Annunzio. Fu Bergamini a introdurre l’uso di un elegante carattere tipografico, l’elzevir, di matrice olandese, che da allora fu sinonimo di scrittura altrettanto elegante, condensata nell’articolo di apertura: l’elzeviro, appunto, palestra di una prosa d’arte che via via, nel tempo, avrebbe però trovato sempre più detrattori che ammiratori per il suo elitarismo e il distacco da temi e problemi di più urgente attualità.
una lunga parabola
In effetti, la lunga parabola della “terza” iniziò a declinare, nella seconda metà del secolo, proprio per la crescente consapevolezza della sua raffinata ma alla fin fine futile, autoreferenziale fisionomia di “torre d’avorio” della cultura, di recinto riservato a pochi “addetti ai lavori” per l’esibizione di narcisistiche fumisterie, ben lontane dalla vita reale e dalla tumultuosa evoluzione che, dal secondo dopoguerra, stava investendo la società italiana, i suoi costumi, le sue necessità, i suoi rapporti – appunto – con una cultura più viva e dinamica, che aborriva quanto sapesse di vecchio e di stantio. E di questo, per sua sfortuna, sapeva la terza pagina. Ad abolirla cominciò, nel 1956, un altro giornale neonato, “Il Giorno”, che inserì le cronache culturali nelle pagine interne. Ma fu anche l’avanzare delle nuove tecnologie a favorirne il lungo tramonto: il passaggio, ad esempio, dalla composizione “a caldo” (il giornale “di piombo”, con le tipografie crepitanti di linotypes) alla fotocomposizione, all’offset, e – più tardi – all’avvento dell’era del computer, in cui alla macchina da scrivere sarebbe subentrato, irreversibilmente, il videoterminale.
vittima illustre
Sarebbe cambiato traumaticamente il mondo dei giornali e il modo di fare i giornali. E la terza pagina sarebbe stata la vittima forse più illustre di una serie di shock e di mutazioni che avrebbero inciso sulla struttura stessa del giornale quotidiano, con nuove esigenze grafiche e contenutistiche.
ultimo addio
Risale al 1976 la nascita di “Repubblica”, in un formato inedito per l’Italia e con la sezione culturale collocata nelle due pagine centrali. Subentrarono poi i supplementi o gli inserti culturali, il “Mercurio” di “Repubblica” appunto, le pagine domenicali del “Sole 24 Ore”. Si sarebbe dovuti però arrivare al 1989 per far decidere anche “La Stampa” a dire ufficialmente addio alla “terza”, scelta cui si risolse pure il “Corriere della Sera” tre anni dopo.
E oggi? Con il “cartaceo” che declina e i blog che impazzano? Chissà quale diavoleria (magari on-line) avrebbe escogitato Alberto Bergamini. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








