Aldo Masullo: «Con la pandemia la natura si sta vendicando del progresso umano»
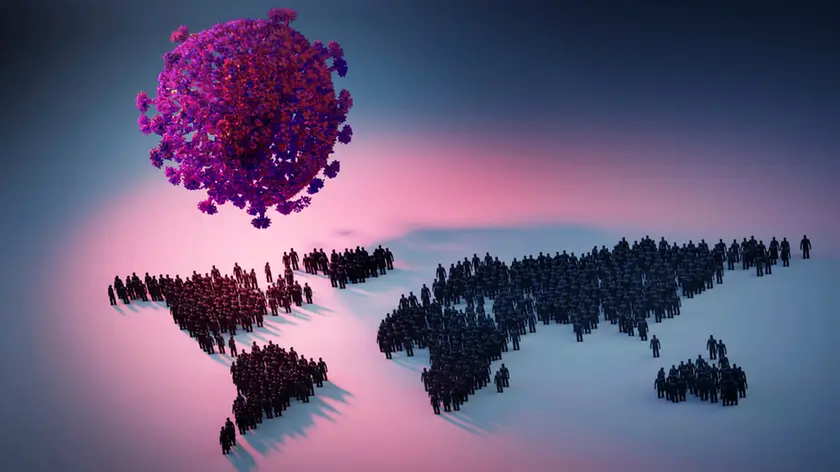
l’intervista
Marta Herzbruch
Noto al grande pubblico per i suoi interventi televisivi e sulla stampa nazionale, nel suo lungo cammino filosofico Aldo Masullo ha affrontato temi che oggi appaiono più che mai pregnanti come la “paticità”, come la definisce, la solitudine e la grazia. Masullo ha appena compiuto 97 anni, e lo abbiamo raggiunto per telefono a Napoli, nella sua casa sul Vomero. Tra un ricordo di Trieste e altro, racconta la sua visione della pandemia.
I figli del boom economico son quelli soffrono di più per l'attuale privazione di libertà, mentre appare più coraggiosa la reazione dei giovani. Come se lo spiega?
«I cinquanta/sessantenni - risponde Masullo -erano in qualche modo viziati da una realtà che - con tutte le sue difficoltà - era tuttavia capace di dare soddisfazione a molte delle loro aspirazioni, e ora si vedono defraudati del vizio di vivere relativamente bene. I più giovani appartengono invece a una generazione che già stava scivolando in grandi difficoltà di carattere economico e sociale. Sicché dinanzi a questa novità di vita così - potremmo dire – strampalata, non fanno altro che rassegnarsi; una rassegnazione che sta tra l'ironico e l'indispettito, ma comunque piena di fermenti positivi».
Lei ha associato alla pandemia una forma di solidarietà che ha chiamato “pan-patìa”. È riconducibile al binomio patire/vivere a cui lei ha dedicato tanti saggi?
«Certamente, quello è proprio il concetto chiave del mio pensiero, cioè il carattere “patico” dell'esistenza, che è sempre un pensare a partire dalla sofferenza della vita vissuta. Oggi questa condizione propria dell'esistere umano si è generalizzata al punto d'essere un “pan”, cioè un tutto. È come se fossimo da ogni parte ormai immersi in questa sorte collettiva di sofferenza, che non ha un nome preciso, che non si definisce in un modo particolare. È una pura e semplice sofferenza di condizione, di tempi, di epoca. È la sofferenza di una intera società».
Cosa farebbe se potesse passeggiare tra le vie di Trieste che lei ben conosce, così vuote, silenziose?
«Da un lato sentirei tutto il pathos di quelle strade cariche di storia, dove il pathos è più massicciamente presente che altrove. Dall'altro trasformerei questa sofferenza inedita – se mi si consente – in un piacere, in un gusto particolare. Il gusto delle cose tipicamente umane che improvvisamente precipitano e dei sentimenti più sottili che improvvisamente vengono strappati e delle aspirazioni silenziose che improvvisamente vengono turbate dalla realtà attuale. Mi affiderei a questo gioco di emozioni, che naturalmente può avere anche del masochistico, perché finiremmo per godere del nostro dolore. E questo mi sembra che sia l'aspetto più sottilmente velenoso di questa situazione».
A differenza di malattie sociali come la peste, il Coronavirus ha una diversa componente di classe, preferisce viaggiare in business class e ha colpito in primis soggetti che avevano un'alta mobilità. A caduta ha interessato gli elementi più stanziali e deboli della società. È un virus epidem-ideologico?
«Domanda molto acuta. Certamente questa scala discendente di diffusione del contagio è come se disegnasse nuove classi sociali e sottolineasse la distanza che c'è tra alcuni gruppi sociali e altri. Questo è l'inevitabile carattere di una malattia, di un contagio, che viene innanzi tutto a colpire la mobilità delle persone. Direi che è un vendicativo attacco della natura contro il progresso e crea una distinzione di classe nuova, basata sul movimento (tipicamente recente della storia sociale) e sull'immobilismo (caratteristico delle società tradizionali). Potremmo dire che l'attuale pandemia colpisca in modo tale da apparire come la sostenitrice della vecchia immobilità e la giustiziera della nuova mobilità».
Nel suo libro “L'arcisenso. Dialettica della solitudine”, lei analizza il significato del toccarsi tra esseri umani. Una serie di gesti spontanei come l'abbraccio saranno censurati ancora a lungo. Con quali conseguenze?
«Penso che avremo l'accentuarsi di quella che io chiamo la “in-comunicatività” tra essere umano e essere umano. Poiché la vita umana è radicalmente auto-centrata, ogni individuo non può comunicare la sua interna esperienza se non attraverso delle finzioni, non direttamente. Quest'impossibilità di comunicare direttamente sarà come accentuata, direi riconosciuta quasi come modello della vita umana a cui attenersi. Certo, quando questa ventata di isolamenti cesserà, probabilmente gli uomini torneranno ad abbracciarsi, anzi con maggiore impeto di prima, anche se sarà un impeto soffocato mentre dovrebbe essere un impeto liberatorio».
Come usare questo tempo di quarantena?
«Suggerirei di usare il tempo d'immobilità materiale attivando la mobilità mentale. Per esempio incominciando a ripensare ai momenti cruciali della nostra attività finora svolta, ai momenti cruciali delle forme di vita sociale che in questo momento ci siamo lasciati alle spalle, per cercare di capire cosa non funziona o non ha funzionato, e in che modo dovremmo modificare gli aspetti fondamentali della nostra vita individuale, ma anche della nostra organizzazione sociale e politica. Abbiamo per così dire uno spazio per esercitarci a un cambiamento che non sarebbe più un cambiamento imposto dall'esterno, ma un cambiamento - se non prodotto - certamente favorito da noi stessi». —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








