“Americano il creatòr” Quando Saba ideava versi per la pubblicità dei film
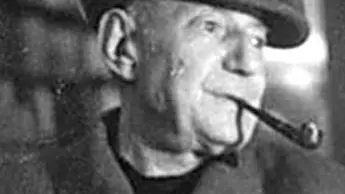
La storia
Un secolo fa, il vero Cinema Paradiso era a Trieste in via Dante, e si chiamava Cinema Italia. “È indubbiamente il più aristocratico ritrovo della città per gli amanti dell’arte muta”, sentenziava il “Piccolo”. Aveva una cassiera che staccava i biglietti con guanti lunghi fino alle ascelle, un ex capitano marittimo che a ogni ora andava in sala a prendere la temperatura, aveva nell’atrio pannelli dipinti da Vito Timmel e nella sala d’aspetto riviste e giornali francesi e inglesi. E soprattutto, aveva uno dei massimi poeti del’900, Umberto Saba, che ne curava la pubblicità scrivendo versi promozionali sui film, in foglietti di programma distribuiti in sala. Questo favoloso incontro fra la quinta e la settima arte, la poesia e il cinema, inizia dunque 100 anni fa, nel febbraio 1919, quando Saba, congedato dopo la guerra, ritorna a Trieste con la famiglia. Stabilitosi in via Crispi 56, dove abiterà fino alla morte, il giovane e non ancora affermato poeta si trova a trentasei anni a doversi cercare un’occupazione. Fino a quel momento è vissuto di rendita per un generoso lascito (ormai quasi esaurito) della zia Regina. Il cognato Enrico Woelfler ha intanto riaperto con grandi ambizioni il Cinema Ideal di via Dante, ribattezzandolo Italia. È un tipo con cui Saba non va d’accordo in niente. Ma la moglie Lina convince entrambi che sia proprio Umberto, col suo estro poetico, a curare la pubblicità della sala, che aveva fama di essere la più lussuosa di Trieste. Per il “Piccolo”, il Cinema Italia “non accoglie che films di assoluta prima visione per la città e scelte con criteri d’arte. Situato in posizione centrica, anche l’aspetto di questo cinematografo è di un’impareggiabile distinzione: un vero gioiello del buon gusto e dello chic”.
Saba sembra accingersi a quest’attività di promozione senza alcun atteggiamento snob di distacco. Anzi, come osserva Elvio Guagnini, “al centro della sua poesia c’è sempre stato il desiderio di immergersi nel flusso della vita (‘dentro la calda/vita di tutti’), dedicando una particolare attenzione alle manifestazioni della società moderna e di massa, come il cinema o, più tardi, il calcio”. E infatti, dall’unica lirica su foglietto ritrovata di quella serie (pubblicata sulla rivista “Ciemme” nel 1997), traspare la volontà di raccontare il cinema in modo gioioso, vitale, riassumendo in pochi versi lo spirito del film, che in questo caso è “La tigre sacra” di Lloyd B. Carleton: “La tigre sacra: / fresche venture/ stragi, paure/ drammi d’amor. / La tigre sacra/ vien di lontano/ n’è americano, / il creator. / La tigre sacra/ teme ciascuno/ ma n’è ciascuno/ l’ammirator. (Miss Ruth Roland protagonista)”.
Un altro amore
Il poeta, però, non coltiva molto a lungo questo impegno. A pochi passi dal Cinema Italia, in via San Nicolò, c’è una libreria con 28mila volumi che il proprietario, un ebreo fiumano, mette in vendita per 5mila lire, un affarone. Saba si fa avanti in società con l’amico Giorgio Fano, ma presto la proprietà rimane al solo Saba, che inizia così l’attività sotto il nome di “Libreria Antica e Moderna” il 1° ottobre 1919. A ricordo del periodo di Saba al Cinema Italia restano la targa commemorativa sul palazzo ex Ras in via Dante, dov’era l’ingresso, e l’insegna sbiadita ma ancora visibile Cineitalia sul lato posteriore in via Santa Caterina. Anche se breve, questa esperienza di Saba nel cinema non rimane tuttavia episodica, ed è segnalata come una delle prime e più significative tappe dell’attrazione fatale fra gli intellettuali e la settima arte. Alle origini, il cinema aveva avuto ad esempio una testimonianza letteraria di vaglia, con Emile Zola che riferisce di una proiezione dei Lumière. In Italia, Gozzano e Verga si cimentano con sceneggiature, ma bisogna aspettare D’Annunzio che firmi “Cabiria” nel 1914 per trovare un letterato davvero coinvolto nella nuova arte, mentre Pirandello due anni dopo scrive “Si gira…”.
Passione di celluloide
Trieste da parte sua, pur essendo la “città di carta” per antonomasia, dimostra tuttavia una passione per la celluloide molto precoce e vivace da parte dei suoi letterati. Prima di Saba, in città era stato James Joyce ad accarezzare l’idea di aprire una sala cinematografica, spinto dalla sorella Eva, assidua frequentatrice dei tanti cinema triestini. Joyce apre così la prima sala stabile a Dublino, il Volta, un’attività che dura però solo i primi sei mesi del 1910. E poi tra le due guerre, nel periodo d’oro della Trieste culturale, Alberto Spaini e Manlio Malabotta scrivono di cinema e anche Italo Svevo ne sembra influenzato. Il critico francese Benjamin Crémieux (che contribuì alla sua scoperta) afferma: “Il primo grande merito di Svevo è quello di aver creato un tipo che ha affinità con lo Charlot di Chaplin. Lo Charlot triestino che ci presenta Svevo col nome di Zeno, ha la stessa aspirazione verso la saggezza e l’eroismo dello Charlot cinematografico”. Ed è ancora Saba negli anni’20 a sviluppare il suo pensiero sul cinema con la poesia “Febbre dell’oro” su Chaplin, e con il “Canto dell’amore (Una domenica dopopranzo al cinematografo)”: “Amo la folla qui domenicale/ che in se stessa rigurgita, se appena/ trova un posto, ammirata sta a godersi/ un poco di ottimismo americano”. Una dedica a quel pubblico amato dai giorni del Cinema Italia, di cui anche lui ora fa parte. Infatti, in una lettera a Giuseppe Paratico del’25, Saba dichiara: “Vado al cinematografo quasi ogni sera”. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








