“Aut aut” compie 70 anni dibattiti e pensieri contro l’imbarbarimento
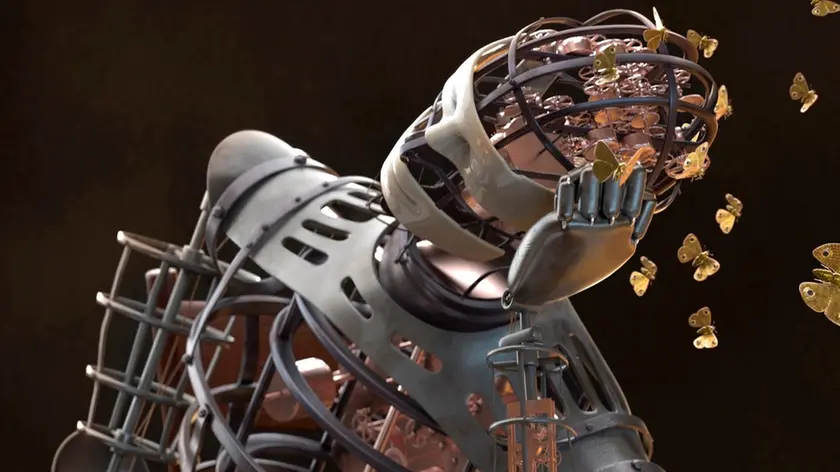
L’anniversario
«Non si può rinunciare alla libertà e non si può costruire rinunciando alla libertà», scriveva Enzo Paci nell’editoriale del primo numero della rivista filosofica “aut aut”. Era il 1951 e nasceva una nuova filosofia che aveva tutte le intenzioni di guardare al rapporto tra libertà culturale e barbarie con un atteggiamento critico, lontano da ogni facile consolazione. In omaggio al settantesimo anniversario, “aut aut” proporrà in giugno il fascicolo “Il gesto filosofico”, «quel gesto – dice il filosofo Pier Aldo Rovatti che dirige la rivista dal 1976 – che, come ci ha insegnato Paci, non è una filosofia ma una postura pratico-etica all’interno del mondo culturale».
Com’è nata “aut aut” e qual era la personalità del suo fondatore Enzo Paci?
«Con l’editoriale del primo numero, nel 1951, si esce da una situazione difficile, che è quella della cultura all’interno del Ventennio, e si entra in una situazione in cui la filosofia, come è intesa da Paci, deve assumere il compito di combattere tutti gli assolutismi, a partire proprio da quelli filosofici. L’esperienza di “aut aut” nasce grazie a Paci e alle sue conoscenze: nel primo numero ci sono personaggi quali Thomas Mann e Gillo Dorfles, che sarà un po’ la spalla di Paci. Si manterrà poi a fasi alterne questa sinergia tra filosofia e letteratura».
Ma chi era Enzo Paci?
«Quando morì, nel 1976, non sono riuscito a parlarne, mi sembrava che ogni cosa si dicesse intorno alla sua figura fosse troppo superficiale. Paci ha lasciato in eredità testi importanti, ha dato un’interpretazione nuova e concreta della fenomenologia: un uomo di grande intelligenza ma anche imprevedibile. Era difficile parlare con lui senza essere sottoposti a un vaglio critico, critico nel senso buono».
Quali quindi i personaggi che hanno fatto la storia di “aut aut”?
«Gillo Dorfless, Luigi Rognoni. Poi gli allievi di Paci: Salvatore Veca, Giovanni Piana, Giairo Daghini, che era il più esposto politicamente, Andrea Bonomi, Giuseppe Semerari. Io inizio a collaborare nel 1963 e nel ’74 ne assumo la vicedirezione».
Dal 1976 ne è direttore, quali le principali linee editoriali?
«La rivista nasceva dal rapporto tra fenomenologia e marxismo, abbiamo articolato diverse posizioni cercando di costruire una consapevolezza critica e culturale. Per esempio è stato dedicato un fascicolo ai “Quaderni rossi” e a Raniero Panzeri, un altro alla Scuola di Budapest, che contava tra i suoi protagonisti Ágnes Heller e ha parecchio influenzato “aut aut”. Negli anni ’70 la rivista spaziava tra filosofia e riflessione critico-politica. Negli anni ’80 in un mio editoriale proposi di rilanciare un pensiero critico, ma stavolta a tutto campo: entrano in gioco nuovi personaggi come Giorgio Agamben, ma la provenienza fenomenologica rimane sempre viva. Questi passaggi sono evidenziati nell’antologia che feci alcuni anni fa, “Il coraggio della filosofia”, edita dal Saggiatore».
È sempre stata una rivista che ha pensato a reclutare giovani intellettuali, ha anche svolto una funzione di talent scout?
«Sicuramente. All’inizio basandosi su un bacino universitario – teniamo presente che il rapporto tra la rivista e l’università passava attraverso la figura anomala di accademico che era Paci – nel senso che “aut aut” è sempre stata una rivista seria, rigorosa, ma senza le stigmate negative dell’accademismo. Paci reclutava giovani anche in base ai suoi tanti interessi, io stesso fui reclutato per un mio intervento pubblico sul rapporto tra fenomenologia e teatro, allora ero ancora studente. Ho mantenuto questo tratto anche attraverso le emergenze più significative all’interno dell’ambito accademico, molti gli studenti reclutati come Fabio Polidori o Edoardo Greblo. Da quando sono uscito dall’università è stato più difficile, negli ultimi anni un altro punto di riferimento è la Scuola di Filosofia, ma in forme diverse. Per esempio ci siamo molto occupati di Foucault e a un certo punto è entrato in redazione Mauro Bertani, uno dei più preparati studiosi del pensatore francese in Italia. O ancora chi si è avvicinato alla rivista pur praticando discipline diverse ma di grande interesse, come gli psicoanalisti Mario Colucci e Francesco Stoppa».
“aut aut” nasce all’insegna della contrapposizione tra libertà della cultura e barbarie, cosa sono oggi libertà e barbarie?
«C’è un imbarbarimento generalizzato, per cui non si può puntare su un tema specifico, si guarda piuttosto all’imbarbarimento della società nel suo complesso. Dall’altra parte la libertà è sempre più difficile da tutelare, la chiamerei pensiero critico e autocritico. Quanto al primo, qualcosa si riesce a fare, basti pensare all’attuale situazione della pandemia; il pensiero autocritico è più difficile ed è quello per cui l’intellettuale dovrebbe avere dei dubbi su se stesso, dovrebbe pensare alla libertà anche come qualcosa che non ha protagonisti che si autodeterminano pensando “io sono libero”. Per essere libero è necessario un percorso complesso perché infine sei sempre “parlato” dagli altri, sei sempre a contatto con la barbarie». —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








