Ennio Emili e la Trieste nera: quella della pace sacrificata: un’Apocalisse letteraria, tra vizio e santità
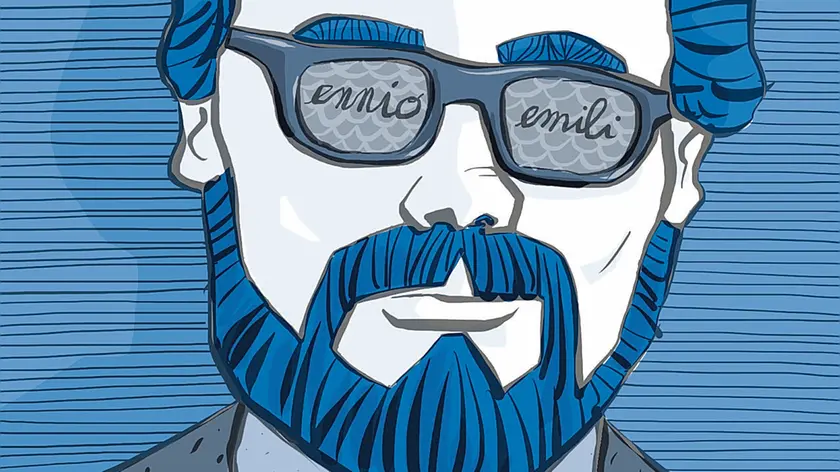
TRIESTE. «Trieste è stato uno dei luoghi santi della letteratura italiana del Novecento». Lo scriveva Carlo Bo, nel saggio introduttivo di quell’opera monumentale che fu “Scrittori triestini del Novecento” (Lint), pubblicata per la prima volta nel 1968 e poi riedito nel 1991. Certo è vero, luogo di santità letteraria, parole non così profetiche se pensiamo a Saba e a Svevo, ma è anche vero che il loro riconoscimento fu tardivo. In fondo c’erano tanti elementi nuovi in gioco, l’aveva sottolineato un critico come Pancrazi, era una questione di lingua, di assillo morale, di identità. E ancora prima – questa volta profetico sì – l’aveva scritto Slataper in quelle “Lettere triestine” (1912) pubblicate nella “Voce” di Prezzolini. Trieste «è composta di tragedia» scriveva, «bisogna sacrificare la pace per esprimerla. Ma esprimerla…». Una lezione che ha coinvolto i grandi autori, ma anche quelli minori, talvolta “minori” non per mancanza di talento, semplicemente per modestia.
La Trieste della pace sacrificata potrebbe essere anche una perfetta definizione di uno scrittore dimenticato, Ennio Emili, nato nel 1937 e scomparso a soli 55 anni, nel 1993. Emili fu artista completo. Sapeva dipingere, e non senza talento, ma poi scelse la scrittura dove operò nel giornalismo, nella saggistica, nella poesia, nel teatro e nella narrativa, anche se i suoi romanzi rimangono ancora inediti. Dagli amici veniva chiamato l’“enfant terrible” della poesia triestina, dove fu fertile soprattutto negli anni ’60 e ’70, pubblicando diverse sillogi per Rebellato e TST, basti ricordare “Le beatitudini” (1970) con prefazione di Fernanda Pivano. Prima c’erano state “Le mani forate” (1966), “Solitudine del giorno martedì” (1966), a cui seguirono molte altre opere.
Un mondo interiore complesso, quello di Emili, e un carattere altrettanto intenso vocato a individuare una sorta di verità spesso divisa tra bene e male, tra vizio e santità, ricorrendo (anche) a un percorso animista, comunque dotato di un linguaggio chiaro, concreto, comunicativo. Antesignano anche sul fronte animalista, così si esprimeva contro la vivisezione già negli anni ‘70: «Dal puzzo fetido di un lager di vivisezione non uscirà la cura del cancro Tutte le grandi scoperte scientifiche si devono a intuizioni».
La sua è sempre stata una battaglia frontale, rispondendo al dettato morale della triestinità letteraria, declinando l’esistenza alla ricerca interiore e all’impegno civile: “Nella mia bocca/con la lingua rotta/piange un silenzio senza parole/piange un silenzio di lacrime/di chiodi e di capinere” (e qui si può riconoscere l’enfant prodige, di certo non ignorava Rimbaud), per poi proseguire verso il cuore del testo: “dov’è andata Edith/la piccola ebra?”.
Ma era poeta di slanci anche più drastici. “Irruento”, lo definiva un’altra poetessa triestina poco ricordata, Lina Galli, che di Emili evidenziava il furore contro la civiltà occidentale, spesso con atteggiamenti apocalittici dove lo scrittore accusava, malediceva, condannava. Era comunque una poesia che abbracciava tutto, benché tra i più rappresentativi esponenti della “triestinità nera”, a contrapposizione della “triestinità bianca” sabiana. Lo scrisse ne “Il maleficio di Trieste: le due triestinità” (1980), un saggio in cui se la città bianca nasce dal vitalismo eroico di Slataper, la nera è «un ganglio dove la bora snervante sembra scaricare tutte le correnti suicidogene, tisiche, oncogene… dell’Europa continentale», insomma una triestinità a cui (anche) Emili si rivolge, un melange di inettitudine, alienazione, paura della malattia, ambiguità, psicoanalisi, suicidio.
Ma non bisogna pensare che fu una poetica capace di sottrarre Emili alla vitalità, anzi: «ho amato follemente Iddio la carne/il misticismo il vizio e l’infinita Morte», scrive ne “Il sorriso”. Non mancano certo i titoli a Emili per essere ricordato, non è l’unico artista triestino che avrebbe meritato una maggior fortuna. Una questione anche di carattere, a un certo punto Emili (come altri poeti locali, Paolo Universo per esempio) preferì tagliare i ponti con il mondo, isolandosi in una poco beata solitudine.
Un autore tormentato, non privo di uno sguardo lucido sulla città, aperto inoltre a correnti letterarie straniere, che solo allora iniziavano ad emergere, come il beat americano: «Aggiungendoci un fascino gotico», aveva riferito durante un’intervista il poeta Claudio Grisancich, amico di Emili fin da giovanissimi, da quando avevano 17 anni: «Ci siamo conosciuti a casa di Anita Pittoni, ma Ennio aveva un carattere polemico e chiuse quasi subito con quell’ambiente. Eravamo rimasti amici, era un uomo pieno di genialità. Ancora giovani ci trovavamo spesso a casa sua per tentare di ideare racconti facendo l’eco a Kafka, così giovani ci sentivamo molto artisti. In camera sua Ennio aveva poi costruito una tenda, lì sotto leggevamo tutti i classici, diceva che era “un’ulteriore stanza dell’anima».
E poi, negli ultimi anni, una strana destabilizzazione, dovuta non solo a un malessere dell’anima ma anche alle vertigini che lo costringevano a un’agorafobia forzata. Una Trieste nera che c’è, indubbiamente, Emili era convinto di quest’aura che primeggiava, lo stesso Slataper, a parere suo, se fosse sopravvissuto alla guerra, sarebbe stato invaso da questo colore: «la vera triestinità è maledetta», scriveva. D’altra parte non mancano esempi di maledetti e suicidi, come ricorda anche Luigi Nacci nel suo “Trieste selvatica” (Laterza), quando ricorda Carlo Stuparich, Michelstaedter, Vivante. Eppure Emili era capace di visionarietà immaginifiche emozionanti, in cui l’uomo era piccola cosa, certo, ma capace di dirci: “E questa era tutto. E questo era infinito”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








