Francesco Merlo racconta la storia d’Italia con il suo “Sillabario dei malintesi”
Ogni lingua è figlia dei suoi tempi, potrebbe sembrare una riflessione di Croce. Ma effettivamente niente come alcune precise parole riciclate o inventate, in un determinato periodo storico, riescono...
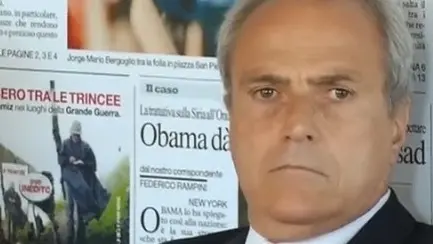
Ogni lingua è figlia dei suoi tempi, potrebbe sembrare una riflessione di Croce. Ma effettivamente niente come alcune precise parole riciclate o inventate, in un determinato periodo storico, riescono a essere più evocative della verità che si vuole raccontare. O non raccontare. Ecco allora il “Sillabario dei malintesi” (Marsilio, pag. 408, euro 20) di Francesco Merlo, che sarà presentato oggi alle 19 a Pordenonelegge al Palazzo della Provincia dal direttore del “Piccolo” Enzo D’Antona.
Un’operazione che è una sorta di vademecum per capire come e perché usiamo certi vocaboli, talvolta assorbiti per abitudine, non sempre consapevoli del loro reale significato. O di ciò che hanno potuto significare in certi periodi. Ci sono parole come “rottamare”, “comunismo”, “lucciole” o “mussulmano” che sono state al centro del dibattito della vita italiana.
Merlo seleziona e affronta quasi ottanta lemmi per più di 400 pagine. Lo fa con creatività e senso storico, precisione e senso della narrazione. D’altra parte è un giornalista raffinato che, appunto, non può far finta di non vedere come pure questo mestiere si stia guastando. «Ho cominciato giovanissimo a raccontare il progetto politico delle convergenze parallele e ora sto qui a raccontare il progetto politico del vaffa», scrive l’autore che prova a comporre la storia d’Italia dal dopoguerra a oggi associando parole invece di date e luoghi. La parola in questione, in questo caso, è: “ossimoro”. Moro e Grillo ne diventano gli esempi, persone in grado di trattenere gli opposti. I lemmi sono tanti e evocativi, da “briganti” a “tangente”, da “referendum” a “corruzione” e talvolta dietro ad alcuni vocaboli si narra anche una storia familiare, affettiva, come per la parola “monarchia”, che traduce anche la figura del nonno dell’autore ma che, soprattutto, vuole comunicarci come si possa raccontare solo ciò che si è sperimentato. Non a caso vengono richiamati personaggi che delle parole facevano ciò che volevano, come Gesualdo Bufalino, il re degli ossimori.
Infine è innegabile una sorta di dizionario geografico, certe parole decifrano meglio di altre alcune metropoli italiane. Di conseguenza ogni territorio traduce un popolo e le sue intenzioni con parole funzionali alla comunicazione, coniugate a un temperamento che sia più o meno furbo, più o meno ambiguo, adatto a repentini trasformismi o a epici cambiamenti. Sempre e comunque dedite a una trama, quella italiana, che è una storia di malintesi.
(m.b.t.)
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche








