Il marketing bellico che pilotava le masse nel primo Novecento
Il saggio del veneziano Giuseppe Ghigi “Oro e piombo, il mercato della Grande Guerra. Pubblicità e propaganda”
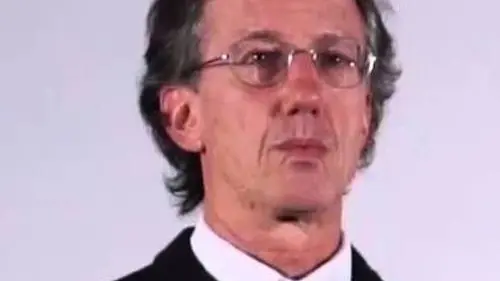
Quando si tratta di vendere, non si guarda in faccia niente e nessuno. Accade oggi, ma accadeva anche ieri, agli albori della Prima Guerra Mondiale, nel tempo dell’Oro e del Piombo. Nel 1917, per le strade di Vienna fu affisso un manifesto disegnato da Alfred Offner per la Wiener Kommerzial Bank. Vi era raffigurata una fila di anonimi soldati che trovavano riparo dietro a scintillanti fiorini d’oro usciti dal conio dell’Impero. Il “bene” che si stava promuovendo era il prestito di guerra, strumento attraverso il quale si mirava a raccogliere le risorse necessarie per far fronte allo sforzo bellico. Si chiedeva alle famiglie di investire nella guerra, facendo leva sul senso di responsabilità individuale e collettivo, sul “dovere patriottico”.
Quel manifesto, simbolo di un’epoca e di una precisa strategia di propaganda, fu tutt’altro che un esempio isolato. E laddove il patriottismo non bastava, allora si usava la carta della colpevolizzazione, del sacrificio, del ricatto morale. Simili campagne di proselitismo bellico furono portate avanti ovunque. Ben presto, però, nell’ambito della comunicazione istituzionale si aggiunse un altro fattore altrettanto inquietante: il marketing, il merchandising, la promozione non solo di ideali patriottici e messaggi politici, ma di veri e propri beni di consumo, spesso superflui, promossi senza il minimo ritegno sfruttando l’immagine dei soldati (felici) al fronte. Il magnifico orologio da taschino “Lip” che permette al poilu francese “di regolare con esattezza i tiri di artiglieria”, le Pep-O-Mint, le caramelle di menta col buco che consentono al tommie in trincea di mantenere fresco il sorriso e l’alito, il vermouth Cinzano nella borraccia del vigoroso fante italiano che si avvia, marciando, al fronte. Grottesco.
Lo spiega in dettaglio lo storico e critico cinematografico veneziano Giuseppe Ghigi, autore del saggio “Oro e Piombo. Il mercato della Grande guerra. Pubblicità, cinema, propaganda 1914 – 1918” (edizioni Rubbettino, pagine 263, euro 16): «Bisognava creare un’ingegneria sociale, un metodo per far fare alle masse quello che vogliono e ciò che devono fare, per avere soldati proni all’obbedienza, cittadini leali allo Stato e passivi acquirenti». Propaganda e pubblicità, allora, agivano di pari passo, lavorando in ensemble con l’obiettivo di accelerare il processo di controllo sociale. «Nessun governo - si legge - poteva sperare di vincere se non aveva dietro di sé una nazione unita e nessun governo l’avrebbe potuta avere se non controllava le menti della propria gente (…). Il controllo dell’opinione pubblica divenne centrale nelle procedure dei governi. Bisognava sedurre quello che Walter Lippmann chiamava “il branco selvaggio”, la massa guidata da forze irrazionali, con strumenti che agissero sull’irrazionale collettivo”. Il nipote di Freud definiva la manipolazione delle opinioni delle masse “il governo invisibile» della società democratica, «un sistema sempre più complesso in cui le masse incolte dovevano avere, naturalmente per il loro bene, il ruolo di spettatori e non di partecipanti».
Altre personalità si sono espresse in merito: secondo Noam Chomsky questa è la nascita della “democrazia degli spettatori” costruita dalla “fabbrica del consenso”; Edward Bernays sosteneva che manipolare le masse equivaleva a «organizzare il caos» della complessità della vita contemporanea, semplificare la vita dei cittadini orientandone le decisioni, i gusti, le scelte. Si doveva “domare gli uomini come si domano le bestie”. Non per niente Goebbels considerava le teorie del pubblicitario statunitense (nonostante questi fosse ebreo) il fondamento della sua azione politica come ministro della propaganda del governo nazista.
Il risultato fu una progressiva “estetizzazione” della politica e un intreccio linguistico pressoché inscindibile tra propaganda e pubblicità. Per esempio, forse non tutti sanno che l’immagine disegnata da Alfred Leete nel settembre del 1914, Your country needs YOU, divenuta icona della Prima guerra mondiale e poi adottata in tutti i paesi coinvolti dal conflitto, è stata realizzata dalla rivista “London Opinion” e non dal governo.
Manifesti, pubblicità, cinema, fotografia, fumetti, s’integrarono tra loro portando progressivamente a un nuovo sistema di comunicazione e di controllo sociale, ma anche commerciale, con lo scopo preciso di vendere merci non necessariamente legate alla guerra. Del resto, come si diceva, la guerre fait vendre.
Con imperdonabile cinismo e del tutto incurante della carneficina che si stava consumando, il corporate war advertising utilizzava stilemi grafico-narrativi accattivanti e quasi fiabeschi per promuovere la vendita di ogni genere di prodotto: sigarette, macchine fotografiche, prodotti per l’igiene personale, apparecchi musicali, e perfino corsetti per signore purché non di importazione dal paese nemico. D’altra parte, sottolinea l’autore, «la ricerca del profitto non è legata a un orizzonte etico». Non deve perciò stupire che guerra e merci fossero vendute secondo le stesse modalità comunicative.
«Il vero target - come sottolinea Ghigi - erano le famiglie, alle quali si chiedeva di inviare ai soldati una particolare penna stilografica, guanti per ripararsi dal freddo, sigarette, alcolici, lucidi da scarpe, gomme da masticare, impermeabili, saponi. È probabile che alcuni di questi articoli venissero anche inviati ai soldati, ma è al consumo civile che mira la pubblicità, e ciò sembra provato dalla siderale lontananza tra le realtà della vita delle trincee e la tipologia delle merci che venivano promosse come indispensabili ai soldati. Forse erano merci lontane anche dalle stesse popolazioni europee ridotte alla fame e a risparmiare su tutto (…). I soldati coabitavano stabilmente con la fame, la sete, le cimici, i topi, le mosche (…). In questa tragica situazione sembra irragionevole che essi non potessero combattere senza possedere un grammofono portatile (…). Più che il lucido Papillon Noir, Nugget, Lutetian & Meltonian, i soldati avrebbero avuto bisogno di scarponi ben impermeabilizzati e di ricambi di fasce e calzini, mentre al contrario, bisognava contarsi le dita dei piedi quando si cavavano le scarpe, per essere sicuri che ci fossero tutte». Le campagne pubblicitarie non risparmiavano neppure le donne e i bambini. Per le signore Helena Rubinstein e Elizabeth Arden lanciavano prodotti cosmetici come antidoto alle rughe causate dalle preoccupazioni dei duri tempi di guerra. Gli stilisti, inoltre, promuovevano nuove mode: il taglio militare, il military curve, più adatto ai tempi per la sua semplicità, e i capelli corti portati a caschetto, decisamente più pratici, soprattutto per le crocerossine. E quando le gonne si accorciano, ecco che un nuovo accessorio si rende indispensabile: il rasoio Milady Décollete della Gillette per la depilazione delle gambe, più lisce e sensuali per il ritorno dei propri uomini in licenza. E i bambini? Anche loro potevano finalmente “giocare alla guerra” grazie a un’ampia scelta di soldatini di piombo, sottomarini o carrarmati giocattolo.
“Oro e Piombo” non è l’ennesimo libro sulla Grande Guerra, ma un avvincente studio che appropriandosi di icone seriali e strategie di propaganda, fonti storiche e interpretazioni sociologiche, getta uno sguardo critico e impietoso sull’alba del Novecento (non troppo lontano dai giorni nostri).
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche
Video








