Inquieto Isherwood dà l’addio a Berlino
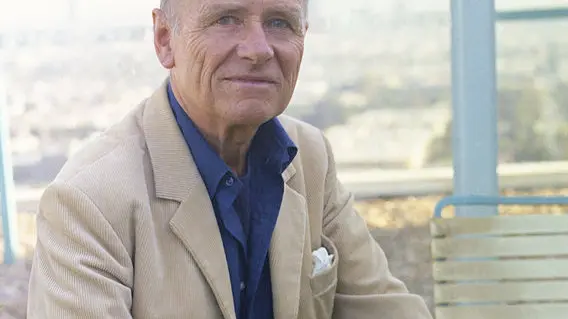
La Germania degli anni Trenta, tra la drammatica decadenza di Weimar e l’ascesa del nazismo al potere, con le notti popolate da ragazzi o ragazze pronti a ogni avventura per un modesto compenso nelle città più ciniche e violente dell’intero continente. Nessun testimone ha saputo raccontare meglio di Christopher Isherwood questo periodo. Lo scrittore inglese ne ha dato conto in “Addio a Berlino” – ora riproposto dalla Adelphi (pagg. 252, euro 12,00) - magnifico romanzo di impianto autobiografico dal quale nel 1972 è stato tratto il film “Cabaret”, con Liza Minnelli nel ruolo della protagonista femminile. Nella metropoli tedesca Isherwood aveva trascorso un lungo e felice soggiorno senza in alcun modo sospettare di essere testimone della «prova generale di un disastro», come dirà in seguito dopo essersi trasferito negli Stati Uniti alla vigilia dello scoppio della guerra. La silenziosa incubazione dell’apocalisse viene narrata con voce tranquilla, attraverso episodi all’apparenza insignificanti: le adorabili svagatezze di un’aspirante attrice, le stravaganze di stranieri troppo ricchi, le patetiche sofferenze di un gruppo di studenti omosessuali, i timori per il futuro di alcuni commercianti ebrei.
Grazie a questi elementi Isherwood cattura e restituisce con implacabile esattezza l’immane catastrofe che sta maturando. «Io sono una macchina fotografica con l'obiettivo aperto, del tutto passiva, che registra e non pensa», ammette. Sulla pellicola, intanto, si fissano i fotogrammi di una festa piena di rumori e di suoni, che piomba nel silenzio appena una ragazza intona una canzone russa «suscitando, come sempre accade, un’impressione di tristezza», oppure le immagini di una fila di uomini con borse di pelle e donne con la rete della spesa «davanti alle serrande abbassate di una grande banca che ha sospeso i pagamenti senza alcun preavviso». Gli antieroi che popolano il libro sono così testimoni inconsapevoli della fine di un’epoca e di una civiltà, illudendosi di essere al riparo dalle tempeste della storia in virtù di un inguaribile ottimismo che impedisce loro di scorgere i segnali di pericolo.
Deliziosamente autoironico, Isherwood racconta se stesso e i suoi compagni d’avventura di quel periodo, dedicando splendidi capitoli all'atmosfera snob delle costose scuole private tedesche, ai riti delle matricole universitarie, alle incrostazioni di un'accademia che ama considerarsi una torre d'avorio immune dai vizi del mondo, agli slanci vitali dei rampolli di una aristocrazia della mente che, a parole, desidera sovvertire le regole dettate dai genitori mentre in realtà attende con ansia l'arrivo dell'assegno mensile che assicura la sopravvivenza quotidiana, al culto di un esasperato narcisismo intellettuale di pochi eletti che rifiutano qualsiasi contatto con chi, teorizzano, non ha le stesse doti in campo artistico.
Ammetterà molti anni più tardi: «Adesso mi sembra strano pensare a noi in quelle piccole stanza berlinesi, esaltati, intenti a declamare poesie, a saltare sui tavoli, a tenere un diario delle nostre vite immaginarie. Strano, quando ci si ricorda che era l'inverno del putsch hitleriano di Monaco e della campagna finale di Mussolini contro i democratici. Suppongo che a quel tempo il nome di Hitler fosse noto ad appena una dozzina di persone del nostro ambiente, al contrario di Mussolini che godeva di una certa popolarità. Lenin, invece, era una figura vagamente esotica che, nelle nostre menti confuse, veniva ritenuto un anarchico e degno quindi di una vaga simpatia».
Alla consapevolezza del reale significato degli eventi di cui è stato testimone Isherwood arriva in seguito, dopo aver lasciato Berlino e aver brevemente sostato in patria. Prima di imbarcarsi nel 1939 su una nave che, insieme a Auden, lo porta negli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle un’Europa in fiamme dove non farà più ritorno per il timore che gli eventi descritti in “Addio a Berlino” possano nuovamente ripetersi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








