La fabbrica delle delazioni Nel “Labirinto Stasi” i prigionieri della Germania dell’Est
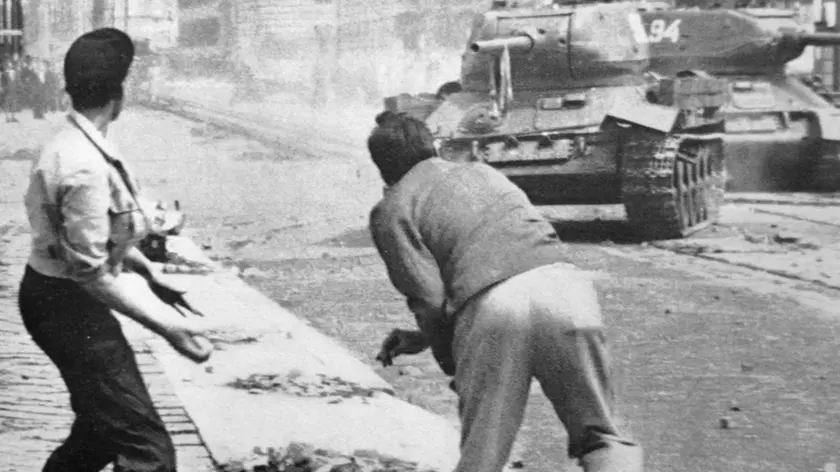
Baladur, condannato a tre anni e tre mesi di reclusione. Reato: aver letto il romanzo di George Orwell 1984.
Gilbert, condannato a due anni e mezzo di reclusione. Reato: aver confezionato e diffuso un opuscolo sul movimento punk.
Andreas, condannato a un anno e mezzo di reclusione. Reato: tentativo di fuga attraverso la Cecoslovacchia.
Sono tre delle migliaia di persone spiate dalla Stasi dalla fine della seconda guerra mondiale alla caduta del Muro di Berlino. I dossier costruiti dallo spionaggio pressoché totale delle loro vite, gli intrecci tra le vite degli spiati e degli spioni, sono il cuore dell’affascinante libro dello studioso Gianluca Falanga “Labirinto Stasi. Vite prigioniere negli archivi della Germania dell’Est” uscito da Feltrinelli (pp. 406, euro 22). Un viaggio rivelatore e perturbante tra i dossier e le testimonianze di un Paese che per anni spiò i suoi cittadini e plasmò una società basata sull’annullamento dell’individuo e la delazione, in un clima di pressione generale e minaccia diffusa.
La portata rivelatrice di questi archivi è tale che nelle settimane che precedettero la caduta del Muro la principale preoccupazione della Stasi fu quella di evitare che le prove del proprio operato cadessero in mano ai cittadini. Ci sono riusciti in minima parte e ora sono accessibili quasi 200 chilometri di documenti cartacei. Oltre ai 47 chilometri di microfilmati, 1,85 milioni di fotografie, 23.250 audiocassette. Una babele ostica e impenetrabile di cartellette rosse, verdi e azzurre, polverosi faldoni, buste ingiallite.
Un materiale esplosivo a cui i cittadini della Ddr si sono avvicinati con in testa una domanda: chi mi ha segnalato alla Stasi? Per Baladur fu il cognato, per Andreas il padre, per molti un familiare o un collega di lavoro. Come facevano i Servizi Segreti a convincere comuni cittadini a lavorare per loro? Falanga ricostruisce quattro categorie di informatori: i corrotti, che spiavano per avere vantaggi economici, i ricattati, mossi dalla paura di perdere il lavoro o mettere nei guai la famiglia, i socialisti convinti e gli ingannati, coloro che erano convinti di aver rifiutato l’ingaggio e venivano utilizzati a loro insaputa. L’obiettivo della Stasi era sempre lo stesso, il controllo sulle vite dei propri cittadini.
Il lavoro di Falanga non si limita a ricostruire il clima paranoico dei decenni post bellici ma, portandoci tra le pieghe più intime della vita nella Ddr, ci fa comprendere come il confine tra vittima e carnefice fosse labile. I confidenti della Stasi erano a volte avversari del regime costretti da circostanze violente ad accettare una collaborazione.
Lo stesso gruppo dirigente che governò la Ddr era composto da funzionari sopravvissuti per miracolo al Terrore stalinista. Chi erano i potenti della Ddr, Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht? Traumatizzati, scampati alle esecuzioni di massa sovietiche solo denunciando alla polizia amici, familiari e compagni di partito. Il vergognoso silenzio su quei fatti era uno dei pilastri sui cui poggiava il mito dello Stato sorto dalla lotta antifascista. La Ddr fu costruita da una classe politica forgiata nel terrore e dominata da enormi paure rimosse, ed è per rompere questa catena di non detto che il lavoro di studiosi come Falanga e il libero accesso agli archivi è un tassello fondamentale per costruire un futuro differente. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








