La Storia siamo noi piccoli e grandi eroi che sanno dire “no”
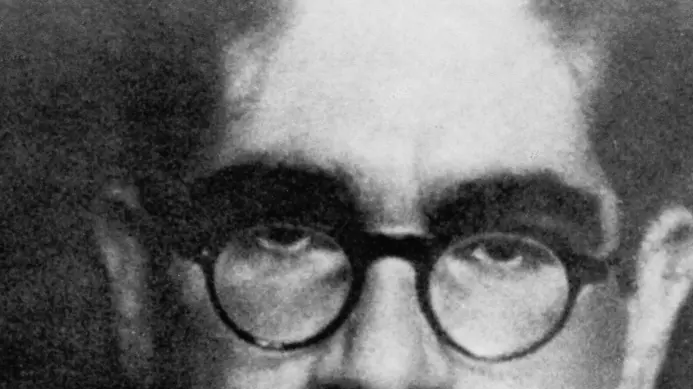
di Alessandro Mezzena Lona
Il professor Scurati aveva un’idea molto precisa. Voleva descrivere l’eroica normalità di Leone Ginzburg. Il giovane docente universitario che, nel 1934, si rifiutò di giurare fedeltà al fascismo. L’altro Scurati, il narratore, puntava i piedi. Reclamava il diritto di raccontare una storia più personale: quella dei suoi nonni, costretti a vivere in un’Italia prigioniera della miseria. Incatenata a una guerra già persa in partenza. Alle follie di una dittatura destinata a seminare macerie.
Per mettersi d’accordo con se stesso, Antonio Scurati (nella foto di Basso Cannarsa) ha deciso di costruire un romanzo che corre su un doppio binario. “Il tempo migliore della nostra vita”, pubblicato da Bompiani, infatti, fa convivere un minuzioso e illuminante viaggio nella vita dell’intellettuale antifascista Ginzburg, morto in carcere nel 1944 per le torture subite, e un affettuoso, personalissimo ricordo dei quattro nonni: Antonio, Peppino, Ida e Angela. Uomini e donne normali nella corrente impetuosa di un tempo fuori dalla norma.
Con questo romanzo, Scurati non solo ha conquistato il Premio Viareggio. Ma sabato 12 settembre si giocherà anche la vittoria al Campiello. Scontrandosi con Vittorio Giacopini e la sua “Mappa” (Il Saggiatore), Carmen Pellegrino e “Cade la terra” (Giunti), Paolo Colagrande e “Senti le rane” (Nottetempo) Marco Balzano e “L’ultimo arrivato” (Sellerio). Conquistando il maggior numero di voti, nella serata finale al Teatro La Fenice condotta da Geppi Cucciari e Neri Marcorè, sarebbe il terzo scrittore a vincere per due volte. Visto che lui, a Venezia, ha già trionfato ner 2005 con “Il sopravvissuto”, ex-aequo con lo scrittore triestino Pino Roveredo.
Ricercatore alla Iulm di Milano, per due volte finalista allo Strega, Scurati ha fatto di questo suo “Tempo” un romanzo corale. Sospeso tra il rispetto rigoroso per le fonti d’archivio e la libertà assoluta di viaggiare tra i ricordi. Distillando una storia di destini diversissimi, eppure alla fine molto simili nell’affrontare la Storia con umano coraggio.
«Lo spunto del mio romanzo arriva da un passato recente - dice Antonio Scurati -. Era l’autunno del 2011, l’Italia sembrava sull’orlo della bancarotta non solo finanziaria, ma anche morale. In quel momento mi è capitato di leggere un articoletto che dava notizia del ritrovamento della lettera autografa con cui, nel 1934, Leone Ginzburg diede le dimissioni dall’Università. In quel momento mi è venuta la voglia di approfondire la storia di questo intellettuale un po’ dimenticato».
Un uomo assai distante dall’Italia dello sfascio?
«Una sorta di contraltare alla miseria morale dei tempi che stiamo vivendo. Nonostante il grande fascino che emanava questa figura, prima mi sono concentrato su una storia più attuale. Quella che racconto nel “Padre infedele”: la trasformazione della figura del padre dentro una crisi coniugale. E lì, parlando di problemi familiari, mi sono tornati in mente i miei nonni».
Ginzburg e i suoi nonni: mondi lontanissimi?
«Mi sono proposto fin dall’inizio di non cercare un forzoso piano di contatto tra questi due mondi. Da una parte la memoria dell’Italia, con tanto di documenti e di testi che si possono consultare negli archivi. Dall’altra, un viaggio personalissimo tra i ricordi di famiglia, tra i racconti tramandati tra parenti. Non mi interessava creare un intreccio che li portasse a incontrarsi. Ho preferito raccontarli in parallelo».
Per arrivare dove?
«A capire se le storie minime di persone che non hanno lasciato il segno nella Storia finiscono per incontrarsi con quelle di personaggi che, invece, tutti ricordiamo. E mi sono accorto che, alla fine, l’incontro può avvenire sul terreno di alcuni dettagli essenziali».
Per esempio?
«C’è un momento in cui Ginzburg, in pieno fascismo, collabora a un lavoro filologico sui frammenti dell’Ariosto. Quasi nello stesso tempo mio nonno Peppino, artista popolare, fa rivivere da puparo la tradizione dei poemi cavallereschi».
Ma c’è di più...
«Sì, perché Ginzburg, straordinario intellettuale, ha dimostrato un’altra grandezza: la dedizione nei confronti degli aspetti più umili del suo lavoro, la cura per gli affetti più vicini a lui come la madre, la moglie, i figli, lo avvicinano a milioni di persone comuni. Che non ebbero le sue doti di docente, scrittore e antifascista, ma coltivarono altre piccole virtù. Quelle più prettamente umane».
Un eroe?
«Non un eroe muscolare, uno che si distingue sul campo di battaglia e poi, magari, nella vita reale si rivela un pessimo uomo. Ginzburg è stato esemplare proprio nella sua straordinaria normalità. E penso che se tanti, nel mondo, fossero stati come lui, forse ci saremmo risparmiati i tanti orrori del ’900».
I suoi nonni hanno sfiorato la grande Storia?
«L’hanno sfiorata e ci sono stati dentro. Senza momenti fatidici. Se non, ad esempio, quando mio nonno Peppino si ritrovò a incontrare Totò, suo amico d’infanzia, diventato ormai una celebrità. Quell’episodio ha turbato un po’ il mio editor».
Perché?
«Nel libro ho voluto raccontarlo due volte, e lui pensava fosse una svista. In realtà, l’ho fatto apposta. Perché è un passaggio in cui una vita umile diventa memoria da tramandare. Io quel nonno non l’ho mai conosciuto. Ma grazie al potere sciamanico della letteratura l’ho potuto ritrovare in una sorta di seduta spiritica di carta».
Si è commosso scrivendo quelle pagine?
«Uno scrittore non dovrebbe mai commuoversi, Gli occhi si annebbiano e, poi, rischia di diventare retorico. Però, sì, mi sono commosso ricordando nonno Peppino e Totò. E anche raccontando gli ultimi istanti di vita di mia nonna Ida. Perché mi ha riportato alla memoria un gorgo di ricordi di quand’ero bambino».
Come convivono lo Scurati scrittore e il docente?
«Per fortuna non sono un vero storico, ma uno studioso eclettico. La mia formazione, se vogliamo, è più filosofica. Ne parlavo l’altro giorno con un amico, il critico Franco Cordelli, che concordava su un fatto: nel mio nuovo romanzo, e in altri libri precedenti, ho cercato di portare in primo piano il sentimento umano della Storia. Ormai abbiamo perso la capacità di sentirci parte di un tempo più grande. Lo diceva anche l’antropologo Ernesto De Martino».
Che cosa diceva?
«Che tutti noi marciamo insieme a una vasta schiera di cui i viventi sono solo una piccola parte. Perché accanto a noi ci sono gli uomini passati, ma anche quelli non ancora nati. Ecco, io credo che Ginzburg, quando nel 1934 dice “no” al fascismo, lo fa perché trova il coraggio di non sentirsi solo nel tempo. Altrimenti, se si fosse guardato attorno, avrebbe constatato che la stragrande maggioranza degli italiani si proclamava fascista. Ma lui era l’erede del Risorgimento, di un Paese nobile».
Nato a Napoli, cresciuto a Venezia, diventato adulto a Milano. Cosa si sente?
«Mi sento veneziano. Vivo da 25 anni a Milano, ma ho ancora un po’ di cadenza veneta. In laguna ci sono arrivato piccolissimo, ho vissuto lì per tutti gli anni che mi hanno formato. Ci ho ambientato anche il mio romanzo post-apocalittico “La seconda mezzanotte”, in cui immaginavo in anticipo lo svuotarsi della città dai residenti e l’arrivo degli immigrati cinesi. A Napoli rimane una metà di me, della mia storia familiare, che mi è molto cara. A Milano riconosco di essere all’avanguardia di molte tendenze sociali. Cosa mi sento? Compiutamente italiano».
Per lei non esistono contrapposizioni?
«No, quando sento parlare di divisioni tra Nord e Sud, è come se qualcuno mi usasse violenza. Se l’Italia, un giorno che spero non arrivi mai, dovesse dividersi, non saprei più chi sono».
Legge molto?
«Ho cominciato tardi a leggere. Anche se ho frequentato un ottimo liceo a Venezia, la lettura è diventata per me appassionante quando ero già all’università. E forse molti libri che sento citare in società non li conosco. Non sono un accumulatore, mi piace approfondire. Gore Vidal, che ho frequentato a Ravello, dove aveva casa, un giorno mi ha detto: “Chi non è diventato lettore prima dei 14 anni è perduto per sempre”. Non è vero, Mia madre ha scoperto il piacere di leggere a 70 anni».
E quando non legge, non scrive?
«Conservo, da buon veneziano, il gusto un po’ plebeo per la crapula. Mi piace trovarmi con gli amici, bere, mangiare. Stare a tavola in compagnia. Ma non amo questa retorica che impera attorno al cibo, al cucinare».
Nel suo libro dice di avere fama di antipatico. È vero?
«Sono scontroso, a volte prendo le situazioni di petto. Non riesco a far tacere la mia vis polemica. E poi, ovviamente, chi non mi ama esagera la mia antipatia. Così, spesso, mi capita di conoscere qualcuno e di trascorrere un po’ di tempo. Alla fine dice sempre le stesse parole: sai che non sei poi antipatico».
Se vincesse di nuovo il Campiello?
«Non sarei il primo. Lo hanno vinto due volte Primo Levi e Carlo Sgorlon. Certo, potrei mentire e dire: ho già conquistato il Viareggio, mi va bene tutto. Non lo farò. Vincere sarebbe una grande gioia, questo è un libro che contiene un pezzo della mia storia. Vorrei che arrivasse a tanti lettori».
alemezlo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








