Le Breton, il professore che scopre sulla strada il piacere della lentezza
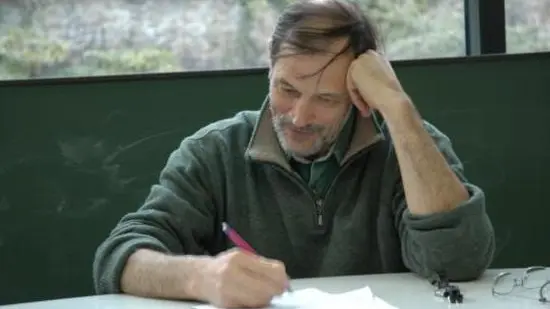
di ALESSANDRO MEZZENA LONA
C’erano prima i piedi delle scarpe. E forse era proprio questo che René Magritte voleva ricordare a chi avrebbe guardare il suo quadro “Il modello rosso”, dipinto nel 1937. Perché in tutto il suo percorso creativo, l’artista, nato a Lessines nel 1898 e morto a Bruxelles nel 1967, si sempre è divertito a seminare dubbi, a smontare certezze. E sussurrare con fantasia che non si può vivere ingabbiati dentro schemi rigidi. Indiscutibili.
Quei piedi che sbucano da un paio di scarpe, che le costringono quasi a dissolversi per poter ritrovare il ruvido abbraccio del terreno, devono aver ispirato anche David Le Breton. Sì, perché il professore dell’Università di Strasburgo, antropologo e sociologo acclamato per molti suoi libri, da anni dedica al ruolo del corpo nella società moderna una ricerca appassionata e fuori dagli schemi. Esplorando l’«Antropologia dei sensi» in un saggio che avrebbe affascinato Italo Calvino quando andava scrivendo i racconti di “Sotto il sole giaguaro”. Affrontando il tema indicibile della sofferenza in “Esperienze del dolore”. Viaggiando tra le simbologie spesso ambigue e indecifrabili di chi rimodella il proprio corpo con tatuaggi, piercing, interventi di chirurgia estetica, in “Signes d’identité”. E leggendo nel volume “La pelle e la traccia” i richiami arcani che molte persone lanciano scrivendo messaggi sulle braccia, sulle gambe, a volte in lingue non immediatamente riconoscibili.
Ma il territorio che Le Breton non si è ancora stancato di esplorare è quello della trasformazione del corpo umano, nel nostro tempo, in una sorta di esoscheletro. In un guscio robotico che, sempre più spesso, decide di modellarsi scegliendo due traiettorie estremamente diverse. Da una parte, quella dell’immobilità patologica. Di un uso disennato delle macchine per coprire percorsi brevissimi. Di una sostituzione del piacere di viaggiare con surrogati tecnologici: mappe web, filmati, immagini, racconti a distanza. Dall’altra, quella di una sfida ai propri limiti che spinge tranquillissimi impiegati a torturare se stessi fino allo stremo delle forze. Trasformandoli in tanti Iron Man, in persone d’acciaio. Capaci di nuotare, correre, pestare sulla bicicletta senza mai fermarsi.
E se c’erano prima i piedi delle scarpe, è anche vero che c’era prima il corpo delle macchine. Così Le Breton, all’inizio del Duemila con “Il mondo a piedi”, l’anno scorso con “Camminare”, ha deciso di esplorare la dimensione della lentezza. Perché «camminare libera dagli obblighi dell’identità. Al di fuori del tessuto familiare della società, non è più necessario sostenere il peso del proprio volto, del proprio nome, della propria persona, della propria condizione sociale»
Le Breton non vuole trasformarsi in uno dei tanti profeti di passaggio. Ma da anni va riflettendo sulla necessità di «rendersi indipendenti dai ritmi stressanti della contemporaneità. Che se, apparentemente, ci rendono vincenti, nella realtà ci fanno solo disperdere energie preziose». C’è un solo modo, secondo il professore francese nato nel 1953, di superare i ritmi folli che la società ci impone: l’ansia, la depressione, il ricorso massiccio a medicinali per ritrovare un briciolo di serenità. Ed è quella di ribellarsi alla routine, di lasciarsi sorprendere da tutte le cose belle che ci circondano. Insomma, bisogna ribellarsi e riscoprire la lentezza. Il gusto delicato del guardarsi attorno, di ritornare a vedere il paesaggio. «Per il buon camminatore non conta tanto la destinazione, quanto il cammino stesso».
Ricordare che i piedi vengono prima delle scarpe, rinunciare alla tirannia delle mode, dell’eleganza ricercata fino all’ossessione, può essere un buon punto di partenza. Perché «i piedi che calpestano il suolo - spiega Le Breton in “Camminare” - non hanno l’aggressività del pneumatico che, imperturbabile, schiaccia tutto ciò che incontra sul suo cammino e imprime la ferita del suo passaggio. Le tracce lasciate dagli animali sono quasi impercettibili. I passi dei camminatori sulla terra sono di un’infinita leggerezza, un soffio sulle pietre, sull’erba o la neve, lasciano solo un granello di sabbia, una traccia di memoria, e non una ferita sul suolo».
Oltre le strade asfaltate si spalanca un mondo che spesso ignoriamo. «Fuori dei sentieri battuti c’è un altro uso del mondo, degli animali, della foresta, delle rocce - afferma Le Breton -. Là dove mancano i segnali depositati dagli altri, dove non c’è traccia di animazionme sociale, in quel denudamento il camminatore incontra la sua storia, la sua interiorità. Arriva persino a non portare più altro peso che quello dello zaino. Si è alleggerito delle preoccupazioni che appesantiscono i suoi passi nel momento precedente la partenza».
Un tempo, camminare significava raggiungere un punto nel mondo che lanciava il suo richiamo. Oggi, avverte Le Breton, noi non abbiamo più niente in comune con chi vedeva il pellegrinaggio come una via per liberarsi dei peccati. Per rimettere in pareggio i conti con la propria coscienza davanti a Dio. «Non si punta più a questo, quanto a trovare un attimo di serenità, di riflessione, di silenzio. Cambiano gli obiettivi, ma il camminare e il sentire la terra sotto i piedi restano il metodo più efficace».
Ci siamo illusi, scriveva Calvino in “Sotto il sole giaguaro”, che il solo modo di viaggiare possibile oggi sia quello di «inghiottire il paese visitato», come se tutto potesse «passare per le labbra e per l’esofago», dal momento che il visibile è già a portata di mano grazie «alla televisione senza muoverti dalla tua poltrona». Abbiamo trasformato, insomma, la gioia di osservare, scoprire, emozionarsi, in un rito alimentare. Digestivo. Mentre Le Breton è convinto che il camminare, il «ricorrere al bosco, alla montagna, alle strade o ai sentieri» lontano dalla routine quotidiana sia «una fuga per riprendere fiato, aguzzare i sensi, rinnovare la propria curiosità e vivere momenti eccezionali».
Se ci si dà ai luoghi, questi riveleranno la loro anima.
alemezlo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








