Leonor Fini, la dea-gatta nella torbida Trieste raccontata da Vollmann
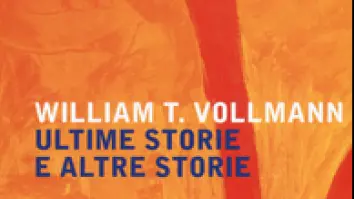
di MARY B. TOLUSSO
Non è facile scrivere su William T. Vollmann, non sono libri semplici, questo è vero, ma certo non più difficili di quelli di David Forrest Wallace. Entrambi penne verticali, anticonsolatorie, penne che, davanti al lettore giusto, ti trascinano lì dove vogliono trascinarti, nella maggior parte dei casi a esplorare zone oscure, quelle che in genere non si ha voglia di indagare. Wallace addirittura, come dichiarò in un'intervista, aveva un complesso di inferiorità nei confronti di William, molto più fertile di lui: per un libro di David, Vollmann ne aveva già compilati cinque.
Ed è vero, i romanzi di Vollmann sono tanti e alcuni non ancora tradotti in Italia. Libri titanici, mai inferiori alle 500 pagine, saghe sulla storia americana, sulla violenza o sul teatro giapponese, romanzi d'amore e di guerra per lo più, dove l'amore è visto da prospettive non usuali, sempre corrotto, in qualche misura. O meglio: interrotto, spesso dalla guerra. Grazie a Fannucci e a Nord prima, e Mondadori poi, si sono potuti leggere i romanzi "Puttane per gloria" oppure "Come un'onda che sale che scende", un'opera energica, dedicata all'analisi della violenza. È il libro di cui Vollmann va più fiero, anche se nel 2005 il National Book Award lo ha vinto con "Europe Central". Romanzo, questo, che ci immerge direttamente nell'incubo delle due grandi dittature totalitarie del Ventesimo secolo.
Ma non è solo uno storico, Vollmann, o un abile reporter, c'è qualcosa che dilata la storia fino a farla diventare a-storica, molto più collettiva nel tempo, rispetto allo spazio. Basti pensare a come ci comunica in bella forma l'universalità della morte, che ci rende assolutamente tutti uguali. E ce lo dice in maniera sporca, diretta. Forse per questo Wallace è conosciuto più di Vollmann, pur avendo iniziato insieme la loro carriera e a disparità di libri. Wallace è più "morbido", per quanto ciò appaia paradossale. Eppure meriterebbero uguale attenzione.
Ma è anche vero che la trasgressività di Vollmann sa auto equilibrarsi, sa dosare la scrittura con certa levità simbolica come in "Ultime storie altre storie" (Mondadori, pag.756, euro 25). Una serie di racconti lunghi capaci di scivolare dalla violenza delle guerre balcaniche al folclore di due città, al di qua e al di là dell'Oceano. Ci racconta il Messico, la sua amata e inquietante Veracruz, ma soprattutto ci racconta Trieste. Una Trieste inedita, va detto, dal fascino torbido e morboso, surreale come lo sa essere Vollmann.
In realtà la poetica triestina, intorno a cui gira il nostro, sarebbe più famigliare a scrittori come Carlo Stuparich, Joyce, e pure a Saba e Svevo, non privi di passione per il lato più oscuro della città. Ma oggi, appunto, per evidenziarlo ci vuole un non triestino. Vollmann, com'è solito, mescola la fiction con dati storici, indaga la Trieste del primo Novecento, per esempio la fortuna costruita dai Circovich, la cui figlia si aggira ancora come un fantasma per le vie, perché poco si è consacrata a quel piacere che è nelle corde della città. Ci sono vampire e donne esangui ma att. enzione, comunque tutte più forti degli uomini, altro dato non sottovalutabile nel Dna giuliano.
Straordinaria è la sua Leonor Fini, dentro una trama folle che si intitola "La dea gatta", un racconto che è un romanzo a sé, dove tutte le statue monumentali scendono dai rispettivi plinti e si relazionano con le persone. In particolare quella di Rossetti, che lascia sola la povera Giovanna, la scultura femminile palmata e in adorazione appena sotto i suoi piedi. Insomma le statue si ribellano all'immobilità, ma nessuna è più indocile di Leonor. Ed è proprio la surreale pittrice ad avere la fortuna di incontrare Rossetti, avvezzo ad adescare giovani donne al Caffè San Marco, destinate a perdere la vita per amor suo. Almeno finché non giunge Leonor, lasciva e troppo intelligente.
«Era una di quelle donne - scrive Vollmann - che nulla può distogliere dai loro piaceri». E poi continua: «E se posso permettermi, godremmo molto di più della nostra vicendevole compagnia se vivessimo e morissimo come lei».
Nel fraseggio del racconto, Leonor diviene la rappresentante, in qualche modo, del gentil sesso triestino, a cui consiglia, in modo più che indiscreto, di godere di molti uomini, «ma di non accettare ordini». Una specie di pedagoga vocata alla libertà, mentre Trieste si insinua tra simboli e metafore di un vivace matriarcato, fino ad essere più che diretta, coinvolgendo la stessa bronzea Giovanna: «Ma cara - le dice - non ti piacerebbe assistere al trionfo della femminilità su una città?».
Insomma Trieste spunta nella sua urbanità impazzita, dove pure le statue si adeguano al climax godereccio: Maria Teresa scappa con un montanaro austriaco, Massimiliano scompare per sedurre delle belle turiste croate e pure Winkelmann si dilegua per concedersi un'avventura con il fattorino dell'Hotel Brulefer. Mentre Leonor ammicca al lettore con un licenzioso saluto: «Assaggia un po' di degradazione, magari ti piace». Decisamente provocatoria.
Poi indaga Redipuglia, Vollmann, in un racconto in cui evoca il cosiddetto "fantasma delle trincee". L'hobby del fantasma è di giocare con i soldatini e, decidendo di andare in cerca di se stesso, scatena la guerra un po' ovunque. Infine tornerà a Trieste, in Canal Grande, perché si crede che tutte le cose morte vi fanno ritorno.
I ritratti d'amore sono inquietanti, va detto, sostenuti da un'ironia sotterranea che pone i soggetti costantemente borderline rispetto alla realtà, nonostante i dati storici, come i quadri di Massimiliano e Carlotta. Ma sull'amore inquieto, sulle romantiche ombre della stravagante Trieste, eccelle il racconto "Una moglie fedele", in cui si narra di una coppia di boemi e dove lui, prematuramente, rimane vedovo. Lei ritorna dal regno dei morti, superando l'insuccesso di Orfeo ed Euridice, ritorna per amore ma sotto forma di vampira. Per proteggere e alimentare la sua sposa lascerà la patria, le figlie moriranno, girerà l'Europa ma ovunque desteranno sospetti e verranno cacciati. Finché Michael e la sua amata estinta approderanno in una città ben disposta alla morte, cioè Trieste, dove anzi la coppia viene considerata tra le migliori. Coppia malsana, ovvio, lui vivo e disposto a qualsiasi sacrificio, lei defunta e resuscitata, praticamente una vampira, «ma non importa - dice il narratore - perché a Trieste c'è sempre qualcosa di umano o d'altro che marcisce sul fondo del Canal Grande».
Nonostante l'abilità di una scrittura capace di farci annusare anche i nauseanti odori di tale orribile devozione, non si può non essere sedotti dal romanticismo di questo eterno innamoramento. È la cifra di Vollmann: rendere seduttiva la morte. Lo fa perfettamente anche nei primi racconti del libro, quando narra la tragica situazione di una Sarajevo assediata, coperta di mine, vissuta da un cronista nella casa di un gruppo di amici dissidenti. Di più quando narra la storia (vera) di Zoran e Zlata, lui serbo, lei bosniaca, una specie di Romeo e Giulietta trucidati sul Vrbanja Most mentre tentano la fuga.
Molto merito va al traduttore Gianni Pannofino, capace di dominare una scrittura a tratti piuttosto barocca e simbolica. Ma il simbolo è una figura che non può essere ignorata in uno scrittore che, in una epistola al lettore, annuncia questo suo come ultimo libro. Le cose che usciranno dopo vanno considerate a firma di un fantasma. Perché Vollmann è già dentro la fine, di pagina in pagina.
William T. Vollmann ha soggiornato nella città nel 1981, nel 2010 e 2012. E ne ha colto tutti gli inafferrabili respiri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








