Oliverio Ferraris: «Il familismo amorale Una malattia quando la famiglia diventa clan»
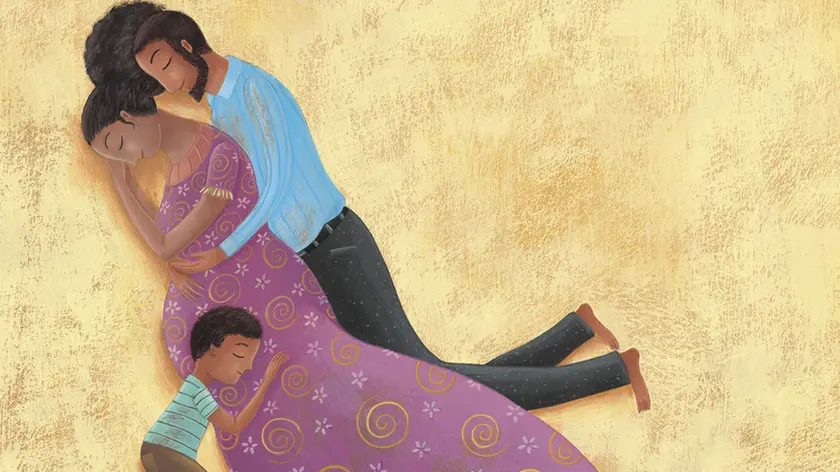
l’intervista
Roberto Carnero
«La famiglia, come la cellula vivente, deve evitare di diventare un sistema rigido e bloccato, e cercare invece di mantenersi mobile e permeabile. È un organismo che necessita di buone relazioni al suo interno e di interscambi fruttuosi con l’esterno, per poter sopravvivere e consentire ai suoi membri di crescere e realizzarsi». Così Anna Oliverio Ferraris, professoressa emerita di Psicologia dello sviluppo presso l’Università di Roma “La Sapienza”, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice nota anche al grande pubblico per i suoi interventi sui media, sempre puntuali, scientificamente fondati ma anche improntati a un concreto buon senso. È da pochi giorni in libreria il suo ultimo saggio, “Famiglia” (Bollati Boringhieri, pp. 176, euro 10), che affronta i molteplici aspetti dell'istituzione familiare nella società di oggi.
Professoressa, qual è lo stato di salute della famiglia nella società italiana?
«Direi non buonissimo. Oggi la famiglia è insidiata da molte incertezze. L'aspetto più problematico è la collocazione lavorativa dei giovani adulti. In un Paese come il nostro, che non offre prospettive ai ragazzi, i più intraprendenti magari cercano una strada all'estero, ma molti invece rimangono con i genitori, prolungando così una condizione di dipendenza, dunque una condizione di per sé infantile o al massimo adolescenziale».
Come mai accade questo?
«Perché in Italia non c'è una politica per i giovani, ai quali di conseguenza manca il futuro, una dimensione progettuale. Un grosso limite della nostra società è quello di non riconoscere il merito. L'esempio negativo viene dall'alto: abbiamo politici e persino ministri senza arte né parte, che occupano posizione di responsabilità senza possedere alcuna competenza. I giovani che si impegnano tanto ma non hanno "sponsorizzazioni" poi non trovano sbocchi, che invece trovano ragazzi raccomandati magari proprio dalla famiglia per le aderenze dei propri genitori».
In un capitolo del suo libro, infatti, lei parla di «familismo amorale».
«È proprio un vizio della società italiana, che si manifesta quando la famiglia si ripiega su se stessa, essendo preoccupata di proteggersi e di perpetuare il proprio potere. La famiglia del resto non è una monade rispetto al resto della società, risente dei problemi del contesto in cui si trova. E l'impoverimento, le difficoltà economiche come quelle che ci troviamo e ci troveremo ad affrontare a causa della pandemia non fanno altro che acuire i problemi».
Come se ne esce?
«Il Family Act annunciato dal Governo mi sembra una buona cosa, speriamo che le promesse verranno mantenute. La cosa più importante è l'impegno a lavorare per ridurre le disuguaglianze, e in questo un ruolo fondamentale è giocato dall'istruzione. Bisogna investire molto su scuola e università. I figli di una famiglia svantaggiata possono essere aiutati da una scuola di qualità. Lo Stato deve tenere nella dovuta considerazione la scienza e la cultura, cosa che però non mi sembra avvenga davvero».
Lei scrive che «i rapporti tra familiari oscillano tra desiderio d’amore, sopraffazione e dolore, tra la ricerca di calore e di solidarietà e il bisogno di autonomia». La famiglia è dunque il luogo dell'ambivalenza, della coesistenza di emozioni e sentimenti contrapposti?
«È inevitabilmente così. Pensiamo ai rapporti tra fratelli: rivalità e gelosia sono sempre presenti. Oggi forse questo si vede meno, perché molte famiglie hanno un solo figlio. Ma anche i rapporti tra genitori e figli spesso non sono sereni. Del resto la famiglia è il luogo dove ci si conosce più in profondità e da più tempo: i figli conoscono i genitori sin dalla nascita. Ma sulla famiglia si può lavorare, sviluppando la solidarietà, la reciprocità, e dunque l'unità».
Eppure l'alto numero di femminicidi denuncia un forte malessere in molte famiglie...
«Negli ultimi decenni si è passati da una struttura di coppia "complementare" a una struttura di coppia "simmetrica". In altre parole, se prima i ruoli dell'uomo e della donna erano definiti, con l'emancipazione femminile si è andati, o si tende, verso una forma di parità. Le donne accettano più facilmente questo cambiamento, perché va a loro vantaggio; molti uomini invece non riescono a metabolizzarlo, magari perché nella loro famiglia d'origine hanno introiettato un modello di tipo tradizionale. Spesso l'aggressività nasce dall'incapacità di accettare questo tipo di mutamenti, cioè la maggiore autonomia della donna».
Un altro cambiamento in atto è quello delle famiglie omogenitoriali. Che cosa ne pensa?
«Ritengo che il desiderio di due persone omosessuali di essere genitori e di crescere dei figli vada preso in considerazione. Questa aspirazione può trasformarsi in un diritto legalmente tutelato. Dobbiamo però porre anche attenzione alla condizione dei figli di queste coppie: il 40-50% dei ragazzi concepiti tramite la fecondazione eterologa si pongono il problema della loro origine, cioè di chi sia il genitore biologico non presente nella coppia che li cresce». —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








