Online le foto del garibaldino che immortalò l’Albania
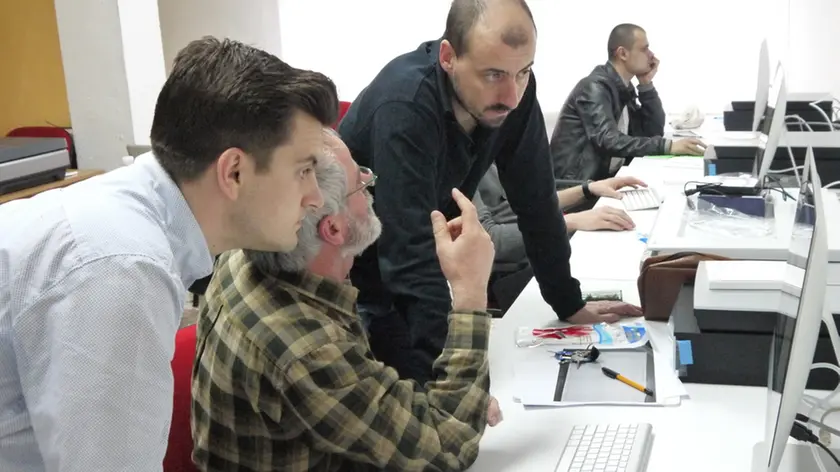
L'archivio fotografico più importante dei Balcani a breve si potrà visitare da casa, sul portale web del Museo Virtuale Marubi, MaViMu (http://mavimu.marubi.gov.al/aspx/Home.aspx). Parte del mezzo milione di lastre fotografiche e film in negativo realizzati da Pietro Marubi e dai suoi successori in Albania, raccolti nella Fototeca nazionale che porta il suo nome, è stata digitalizzata e catalogata secondo gli standard internazionali. Sarà consultabile e diventerà una finestra sulla realtà albanese precedente alla dittatura di Enver Hoxha, mostrando una società plurale, multireligiosa, legata alle tradizioni popolari. Servirà a ricercatori e appassionati di fotografia. Potrà suggerire itinerari turistici sulle tracce del famoso italiano trapiantato nel Paese delle aquile a metà Ottocento. Il progetto MaViMu è sostenuto dall’Undp, l'agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo, in collaborazione con il Ministero della Cultura albanese e l’Ipac, Istituto regionale per il patrimonio culturale, che ha dato un contributo fondamentale nel trasferimento di competenze sull'archiviazione al personale della Fototeca. Il passaggio al digitale garantisce di conservare in buono stato i preziosi documenti delle diverse collezioni e permette di divulgare un patrimonio artistico e culturale il cui interesse è internazionale. La Fototeca conserva gli scatti di Pietro Marubi, dei suoi eredi, Kel e Gegë, e di altri importanti fotografi albanesi, componendo un vero e proprio mosaico antropologico di un'ampia area dei Balcani.
Lo studio di Pietro Marubi apre a Scutari nel 1856. Siamo agli albori della storia della fotografia e la sua è forse la prima fotocamera a comparire in Albania. È di Pietro l'immagine del primo Consolato italiano inaugurato nel 1861 a Scutari. Lui è un garibaldino fuggito dall'Italia dopo la condanna per un omicidio a sfondo politico. Prima si rifugia a Corfù, poi a Valona, per passare a Scutari, centro culturale per eccellenza in Albania. Qui Pietro diventa Pjetër, albanese anche nel nome. Si sposa con Marietta, una levatrice originaria di Gorizia, di vent'anni più vecchia di lui, da cui non ha figli. Così, a seguire le sue orme sono Mati e Mikel Kodheli, i figli dei suoi servitori. Lui li adotta a tutti gli effetti e li manda a studiare a Trieste, nel rinomato studio di Sebastianutti e Benque. Dopo la morte di Mati, è Mikel, detto Kel, a prendere in mano l'attività di Pjeter, compra un nuovo studio e lo intitola "Scritto con la luce". Sarà Gegë, il figlio di Kel, a portare avanti il lavoro della dinastia, fino al 1970. I ritratti delle tre generazioni Marubi sono esposti nell’Ambasciata italiana di Tirana, a dimostrazione del legame forte che unisce le sponde dell'Adriatico. È una connessione che si rinnova nel tempo: in base ai dati Istat, quella albanese è la seconda nazionalità più rappresentata tra gli immigrati nella nostra regione, con circa 12mila presenze sul totale di oltre centomila stranieri in Friuli Venezia Giulia. Ma le radici di una storia comune affondano nei secoli, fino all'epoca della Serenissima, quando l'Adriatico è il mare di Venezia e si intessono continui scambi. L'Albania, terra di passaggio, dopo la caduta di Costantinopoli affronta la pressione ottomana e nasce il mito di Giorgio Castriota, detto Scanderberg, che riesce a fermare l'avanzata turca diventando il difensore della Cristianità, fino alla morte nel 1468. Nel tardo Quattrocento Venezia cede all'Impero ottomano Scutari e Drivasto, le roccaforti cattoliche dell'Albania del nord, e dà la possibilità alla popolazione locale di trasferirsi nelle terre della Serenissima, come ricompensa per la fedeltà e l'aiuto militare avuto per decenni. Viene attuata una politica di accoglienza dei profughi in base al ceto e interi nuclei famigliari emigrano. Alcuni si fermano a Venezia, ma molti vengono inviati in aree più marginali, in Friuli, nel Carso e in Istria.
«Di queste popolazioni non restano molte tracce, a differenza che nel Sud Italia, dove è nota la presenza delle comunità di lingua arberesh», spiega Lucia Nadin, veneziana e cittadina onoraria di Scutari, con una lunga esperienza all'Università di Tirana e all'Istituto italiano di cultura. «Da noi il processo di assimilazione è stato rapido e questa storia si è persa», spiega Nadin, «ma quando sono andata in Albania a insegnare, ho riscoperto un passato che è anche nostro. Mi sono appassionata allo studio delle migrazioni a Venezia tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. C'è ancora molto da ricercare, soprattutto sulla presenza di popolazioni di origine albanese nelle terre friulane e giuliane». Nel suo testo "Venezia e Albania, una storia di incontri e secolari legami", pubblicato dalla Regione Veneto, Lucia Nadin ricorda come molti immigrati furono mandati in Friuli e Istria: Joanne da Scodra è destinato alla chiusura e apertura delle porte della città di Udine nel 1476. Tre anni dopo Stefano Milotino riceve lo stesso incarico, a ricompensa della fedeltà nella lotta contro gli ottomani. L'8 maggio 1479 il Senato di Venezia delibera, per i 110 che avevano combattuto nell'assedio di Scutari, che siano mandati nella zona dell'Isonzo e che ricevano una casa e uno stipendio mensile. Alle famiglie nobili, come i Moneta e gli Ungaro, vengono date terre in Friuli. Gli spostamenti più facili da rintracciare sono quelli dei religiosi, che con l'avanzata ottomana abbandonano la costa dalmata e albanese. Una pista porta a Valvasone, attraverso il testamento del cappellano Luca Spiron. Sono diversi i sacerdoti albanesi nella diocesi di Concordia-Pordenone. Spiron, di famiglia nobile, nasce a Drivasto, baluardo del cattolicesimo. Se ne va alla morte di Scanderberg e, dopo un periodo in Friuli, terra non facile, soggetta a incursioni, si trasferisce a Venezia come cappellano del monastero dei Santi Cosma e Damiano, alla Giudecca. Dal testamento emerge che altri della famiglia Spiron vivono in Friuli: Andrea Spiron fa il maestro di scuola, a dimostrazione del livello culturale elevato. Albanese di Scutari è anche lo scultore del legno Paolo Campsa, tra i maggiori esponenti del rinascimento veneto. I suoi altari, polittici e Madonne si ritrovano in molte chiese del Friuli e dell'Istria. E, infine, ci sono gli immigrati di ceto basso, mandati a popolare le terre più marginali della Serenissima, devastate dai turchi, dalla peste e dalla malaria. La loro storia resta tutta da esplorare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








