Philip Roth, lo scrittore contro sempre in guerra con la pagina
I Meridiani Mondadori lo celebrano, a cinque anni dalla decisione di ritirarsi
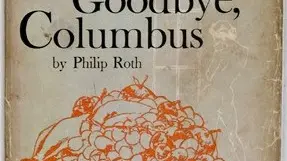
È autunno a Chicago, settembre o forse ottobre del 1956. Di sicuro la luce è tersa, gli alberi sono un fulgore rosso acceso e nel lago di Hyde Park le anatre si preparano a migrare. Due amici pranzano in un pub a pochi passi dall’università dove insegnano. Uno dei due racconta spassose storielle sull’ambiente del country club ebraico del New Jersey, conosciuto nelle intrepide incursioni amorose dell’adolescenza. L’altro lo ascolta divertito e quando si alzano dice: «Perché non le scrivi, queste storie?». Allora l’amico, che si chiama
Philip Roth
e fino a quel momento ha avuto in testa Conrad ed Henry James, se ne va a casa e si mette a scrivere.
Tre anni dopo, appena venticinquenne, Roth pubblica “Goodbye, Columbus”. È l’inizio della liberazione più scatenata che un autore americano abbia mai messo in atto nella pagina e che durerà più di cinquant’anni. Fino al 2012, quando annuncia la decisione di farla finita con la scrittura.
Cinque anni dopo questa famigerata dichiarazione i Meridiani Mondadori celebrano, con un’articolata selezione in tre volumi, l’opera del più controverso degli scrittori americani. Domani esce in libreria
“Romanzi 1959-1986” (pagg. CXXVIII-1888, Euro 80)
, curato da Elèna Mortara, che raccoglie i lavori di Roth dal folgorante esordio a “La controvita”, uno dei suoi libri più complessi e postmodernisti, si potrebbe dire facendogli storcere il naso. In mezzo ci sono: “La mia vita di uomo”, dove Roth mette per la prima volta al centro il rapporto tra esperienza biografica e invenzione narrativa; i quattro romanzi di Zuckerman “Lo scrittore fantasma”, “Zuckerman scatenato”, “Lezione di anatomia”, “L’orgia di Praga”. E soprattutto il suo capolavoro “Il lamento di Portnoy”.
Roth ha vitalizzato la letteratura come pochi altri autori contemporanei, ha spalancato nuove vie, conquistato un pubblico vastissimo, dato vita a dibattiti sanguinosi e accuse feroci, ispirato scrittori di tutti i continenti. Qual è il segreto dell’effetto Roth?
Rileggendo le pagine del Meridiano, mi è tornata vivissima la sensazione quasi fisica che provai quando lo lessi per la prima volta. Un brivido di piacere davanti a un’inaudita libertà, eccolo il regalo o l’insegnamento di Roth. Uno scrittore che padroneggia così a fondo la migliore tradizione letteraria, le più sofisticate invenzioni della lingua, le conturbanti pieghe dell’animo umano, da poterle far saltare in aria senza tanti riguardi. Perché Roth non ha mai fatto altro, di romanzo e in romanzo, con alti e bassi, con una potenza sempre maggiore. Si è liberato di qualsiasi catena: dei temi della buona letteratura, dell’educata lingua canonizzata, della timidezza dell’ebreo dei sobborghi davanti ai critici privilegiati e non ebrei delle prestigiose riviste letterarie, delle madri e dei padri, dei rabbini che lo accusavano di antisemitismo. E allo stesso tempo a quelle catene è sempre tornato perché “uno scrittore deve essere insofferente a qualcosa per poter vedere. Uno scrittore ha bisogno di veleni”. E spesso l’antidoto ai veleni è un libro.
Quando uscì, “Goodbye, Columbus” fece alzare la testa a tutti i critici perché faceva con arrogante sicurezza qualcosa di letterariamente audace: raccontare l’America attraverso i sobborghi ebraici. Sì, perché è l’America la grande ossessione di Roth, nipote di immigrati dall’est Europa a fine Ottocento, cresciuto in un’enclave totalmente ebraica vendendo hot dog e patatine e giocando a baseball. L’America del sogno e dei fallimenti politici, dell’antisemitismo e della vittoria sul nazismo, delle ragazze libere e del puritanesimo. Contrasti e libertà, la linfa per i capolavori di Roth, ciò che lo rende il più americano degli autori.
Ma il suo percorso di scrittore non è la catena di successi che i molti riconoscimenti fanno immaginare. A fianco degli stati di grazia, della tonificante attenzione della critica e dei lettori, la sua scrittura è costellata di inceppi, abbandoni, delusioni, riscritture e momenti bui.
Dopo l’esordio emozionante (fin troppo raffinato, nota bene Saul Bellow), dopo il successo della “pastoralizzazione del ghetto”, capace di raccontare “nuovi ebrei, liberati, normalizzati, ridicoli e meravigliosi” dove Brenda Patimkin detronizza Anne Frank in un trionfo di “prati verdi, ebrei bianchi”, di “sesso a tutto spiano, frutta fresca, e le Dieci Grandi del basket”, ecco arrivare gli ostacoli. Roth è alle prese con il fallimento del suo matrimonio e i due romanzi successivi raccolgono critiche tiepide.
Poi nel 1969, dopo quattro false partenze, arriva Portnoy ed è la rivoluzione. Il successo è immediato e travolgente. Nella costosa edizione rilegata vende 420 mila copie, in paperback supera i 3 milioni e mezzo. Roth si scrolla di dosso qualsiasi deferenza verso la grande letteratura ed è il trionfo del talento. La libertà senza freni di un uno scrittore che a 36 anni scopre e conquista l’America attraverso le ossessioni masturbatorie-intellettuali di un super controllato figlio ebreo e le sue inarrestabili avventure sessuali con le conturbanti shikse. La libertà di uno scrittore che ha letto tutto, studiato tutto e ora si lascia alle spalle la buona educazione per dimostrarci che con la lingua fa quello che vuole, mescola alto e basso, espressioni yiddish e slang, fino al liberatorio urlo finale. E ci vuole un coraggio sicuro per chiudere con un Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh….! quello che è destinato a diventare uno dei capolavori della letteratura. Un coraggio e un talento così sfavillanti che sono un doppio cazzotto agli intellettuali politicizzati, al mondo ebraico più conservatore, alle femministe fedeli alle proprie inibizioni che non lo perdonano. Roth scappa a Yaddo per sfuggire al pandemonio che ha scatenato.
Bisogna poi aspettare dieci anni perché sorprenda di nuovo. Nel 1979 pubblica “Lo scrittore fantasma”, ed è una svolta decisiva. Fa il suo ingresso nell’universo rothiano Nathan Zuckerman, il più riuscito dei suoi doppi, il personaggio attraverso il quale la sua autobiografia prende la risonanza di un mito letterario. Gli anni di Zuckerman sono quelli segnati dai molti viaggi in Cecoslovacchia. Il contesto opprimente, di libertà vigilata e sospettosa che lo investe a Praga non può che essere stimolante per uno scrittore che si è sempre servito del contrasto, delle restrizioni e dei controlli per alimentare la sfrontata energia delle pagine. Kafka ne è il nume tutelare. Da ultimo in questo Meridiano, troviamo la “La controvita”. Un controromanzo verrebbe da dire, nel senso che riunisce tutto ciò che la gente non vuole nei romanzi: il gioco di specchi, il proliferare dei punti di vista, i molti arresti e ripartenze. “La controvita” è forse uno dei libri che più mette a nudo il meccanismo di scrittura di Roth, l’antagonismo come punto di forza della narrazione, il suo continuo tentativo di liberarsi del senso di colpa, dei genitori, della letteratura e il desiderio di essere ogni volta rincatenato. È un libro di passaggio verso la maturità.
Dopo che i grandi slanci ribellisti sono stati accolti, quando non c’è più niente da rivendicare o da “sfruttare”, Roth è pronto per lanciarsi verso i grandi romanzi della maturità. Altre fatiche, perché la grandezza di Roth non nasce da un processo facile e spontaneo, la scrittura per lui è sempre una lotta e da qui ne scaturisce tutta la naturalezza. Per questo, in una parete del suo studio in Connecticut, è appeso un tabellone dell’alfabeto, “per ricordarmi che sono soltanto lettere, santo cielo… lettere che conosco benissimo”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche








