Richard Rogers, c’è un posto per tutti nella Trieste dove il bisnonno ideò il tram di Opicina
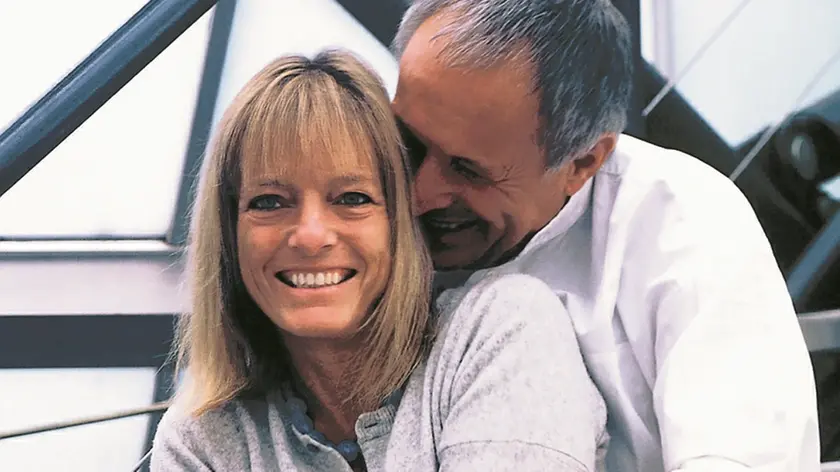
TRIESTE Nel passato di Richard Rogers, uno dei grandi dell’architettura mondiale, c’è Trieste. Inaspettata geografia per l’architetto che nel 2007 vinse il Pritzker Prize (un po’ il Nobel dell’architettura), e che insieme al “nostro” Renzo Piano disegnò negli anni Settanta il suo edificio forse più famoso, il Pompidou a Parigi. A 86 anni, Richard Rogers vive a Londra ma costruisce in tutto il mondo.
Sorriso contagioso, camicie rosa shocking, verde o arancione (è stato citato dalla rivista di moda GQ tra gli uomini più eleganti d’Inghilterra), una visione dell’architettura ancora in movimento. E Trieste? È un suo luogo del cuore, ci racconta: «Mia madre Dada nacque lì, e lì imparò l’inglese andando a lezione da James Joyce. Era legatissima alla città, e alla sua famiglia, i Geiringer; legatissima a tutto quello che era Mitteleuropa».
Ma poi nel 1932 Dada sposa Nino, amico d’infanzia, un medico cresciuto a Venezia; si trasferiscono a Firenze. Richard nasce un anno dopo: e cresce, come ricorda, fra gli arredi modernisti del cugino Ernesto Nathan Rogers e una vista sulla cupola del Brunelleschi. Però nel 1938 – venti di guerra – la famiglia decide di trasferirsi a Londra, grazie al passaporto del padre (o meglio del nonno). E quindi addio Italia. Rogers è bambino nella grigia Londra della guerra, del razionamento, delle stufe a carbone.
Ma Trieste continua ad aspettare Rogers: ci arriva finalmente negli anni Cinquanta, incaricato dal National Service, il servizio militare britannico. All’epoca infatti la città, appena uscita dalla seconda guerra mondiale, era sotto il controllo delle forze alleate. E per lui era (anche) la Trieste dei nonni. «Il nonno Riccardo Geiringer, dirigente delle Generali, mi regalò l’abbonamento all’opera: fantastico. Lì è nata una passione per l’opera e la musica classica che dura ancora».
Anche se, stranamente, nella lunga lista di edifici premiati e firmati da Rogers, un teatro non c’è: progetti in tutto il mondo, dal Millennium Dome a Londra, fino al 3 World Trade a Manhattan sul sito di Ground Zero (un grattacielo firmato insieme a Richard Paul, per Rogers Stirk Harbour + Partners). Ma torniamo a Trieste, al suo imprinting. Cos’altro ricorda di quegli anni triestini? «Che andavo, appena potevo, dai nonni, a Villa Geiringer a Scorcola, costruita dal mio bisnonno Eugenio. Lì, il fine settimana, stavo con i nonni e i loro amici, giocavo a scacchi…”. Alla Villa, realizzata in stile “medievale” come andava di moda all’epoca (stiamo parlando di fine Ottocento), si arrivava con il tram di Opcina: idea, questa, del bisnonno. E non solo! Porta la firma di Eugenio Geiringer, ingegnere e architetto, il palazzo del Municipio triestino, e l’edificio dove ora si trova l’Istituto nautico di piazza Hortis; così come quello che è ora l’hotel Duchi d’Aosta. Fu anche il promotore e il progettista della linea ferroviaria che da Trieste arrivava a Vienna. Vera Mitteleuropa, dunque, nel sangue di Rogers, che ora è sir: è diventato barone di Riverside (è stato nominato Lord nel 1996). Sempre in Italia nasce il primo interesse per l’architettura. «Perché stare in Italia voleva dire vedere molto di più il cugino di mio padre, Ernesto Nathan Rogers, che aveva aperto uno studio a Milano già negli anni Trenta». E che studio era, il mitico Bbpr: che firmò, tra gli altri capolavori modernisti, la Torre Velasca a Milano.
Di quegli anni invece, gli anni Cinquanta della ricostruzione, rimane a Trieste la vecchia stazione di servizio per la raffineria Aquila, sulle rive. Sempre firmata Bbpr, e infatti ora si chiama Stazione Rogers, ben nota ai triestini. E Rogers sottolinea: «Ho sempre trovato molto interessanti i porti». Dalla madre Dada, Richard prende l’amore per il colore. E i materiali. «Era una “potter”, faceva ceramiche; mi regalò le prime quando mi sposai, quasi un “sostituto” della casa che lasciavo. Le ho ancora», racconta. «Mi ha insegnato ad amare ciò che è bello e nuovo: fu lei a portarmi, nel dopoguerra a Londra, a vedere una mostra di Picasso al Victoria & Albert, che all’epoca fece scandalo. Da allora i materiali sono sempre stati importanti per me: anche quelli tecnologicamente più innovativi».
Materiali e struttura, che nell’architettura di Rogers è sempre stata inside/out, al rovescio, a partire appunto dal Pompidou studiato con Renzo Piano: «La mia architettura si può leggere: chi guarda un mio edificio riesce a capire come è costruito. La struttura è fuori, all’esterno». Ma l’inside/out del Pompidou, in quegli anni, scatenò polemiche: esibire tutto quello che di solito è nascosto, gli impianti di areazione, di riscaldamento, le scale… Eppure, per lui, diventò un trademark. Lo stesso “stile” usato a Londra per la sede dei Lloyds, costruita nel 1991. E per gli aeroporti ovviamente: quello di Barajas a Madrid (il terminal 4), quello di Heathrow a Londra (il terminal 5).
Solo grattacieli, grandi architetture? In realtà uno dei suoi primi lavori è stata una casa, costruita per i genitori, a Wimbledon, fra il 1968 e il 1969: Parkside. È il primo progetto nato dall’avventura americana: perché Rogers, dopo aver studiato alla mitica università londinese AA Architectural Association, con quella che diventerà la prima moglie, Su Brumwell, era andato a Yale, dove incontra il futuro socio Norman Foster. Da lì un lungo viaggio on the road, tra California e Messico, dove assorbe l’arcobaleno di colori di quelle terre. Parkside, dunque, contiene già il suo approccio: l’uso del colore e di elementi prefabbricati ecosostenibili, trasparenza e flessibilità. Poi arriva il Pompidou, e… il successo. Se Trieste non è più tornata nella vita di Rogers, in compenso c’è l’Italia: «Ho preso casa in Toscana, da vent’anni: nella campagna accanto a Pienza, luogo splendido».
Una casa da patriarca: cinque figli, tredici nipoti, due mogli (la seconda, Ruthie, nella foto in questa pagina insieme a Rogers, è uno chef stellato, ed è lei dietro The River Cafè a Londra; ristorante disegnato da lui, ovviamente). Mentre Trieste aspetta ancora lo sguardo e l’energia di un grande architetto che la rimetta sulla mappa. —
© RIPRODUZIONE RISERVA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








