Seguendo le tracce di Bazlen a Trieste, la città che si conosce per approssimazioni
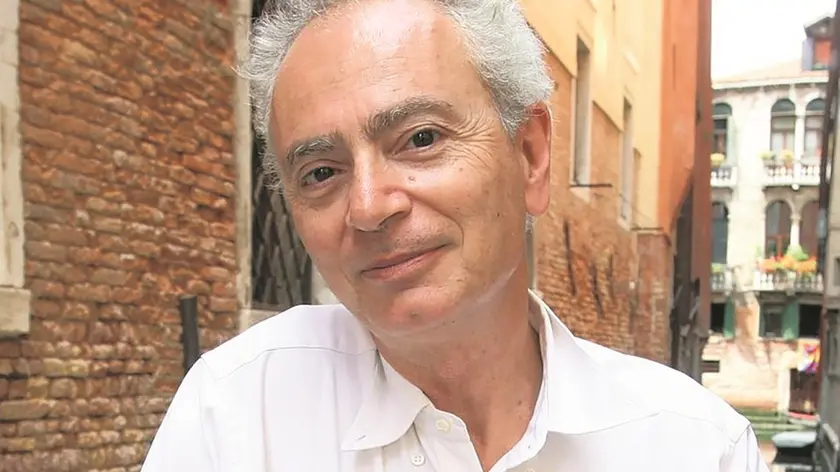
Nel 1983 Daniele Del Giudice pubblicava il suo primo romanzo, Lo stadio di Wimbledon. Era il racconto d'un giovane che voleva capire le ragioni di un personaggio divenuto leggendario, un intellettuale triestino morto da una quindicina d'anni, Bobi Bazlen: aveva contribuito a far conoscere Svevo, ma aveva scelto di non pubblicare nulla di suo, se non note editoriali. Lo scrittore, che si era posto il problema del rapporto tra vita e letteratura, faceva così partire il suo protagonista per Trieste. In questa prospettiva la città diventava metafora letteraria, in particolare di quell'anima mitteleuropea che, ben lontana da palesare qualcosa di preciso, designava piuttosto qualcosa di sfuggente, di avvicinabile solo per approssimazioni. Il giovane sapeva dunque che la sua ricerca non avrebbe portato ad esiti definitivi, come ben rivela la modalità del suo arrivo: il treno con cui giunge da un luogo imprecisato si blocca proprio là dove il paesaggio si chiude tra le rocce e il mare, obbligando il viaggiatore a proseguire a piedi. Ma, stranamente, il paesaggio non gli suggerisce alcuna emozione particolare.
Raggiunta finalmente la stazione, da lì progetta il proprio itinerario esplorativo giornaliero, come fa ogni volta che arriva in città, consapevole che il viaggio, nell'ottica della modernità, non può che ridursi a una ripetitiva pendolarità: come la letteratura, sfiora senza potersi mai fermare in un punto d'arrivo definitivo, ma intanto rivela sempre qualcosa. Appena arrivato, punta allora verso il luogo dove la scrittura si offre in tutte le sue epifanie, una libreria antiquaria. Se l'aspettava piccola e invece gli sembra monumentale nella posizione e nell'ampiezza delle scaffalature,che si allungano fino a una specie di celletta, dove si staglia la gigantografia di Umberto Saba. Ma non trova il libro che cercava: così come non lo trova in un'altra, nel ghetto, dove gli viene spiegato che a Trieste le poche librerie esistenti devono tenere un po' di tutto, ma che anche il tutto ha un suo limite. Afferrato il senso dell'eterno vagare, si accorge di aver voglia di perdersi, per seguire non un percorso preciso, ma una sensazione mentale.
È una giornata lucida, appena fredda quando "vede" il mare, che gli appare strano per la posizione del sole rispetto all'acqua e per il tipo di luce e di colore, abituato come è a distese che scorrono in modo tangenziale, non che cominciano, come qui. Un'altra volta si reca alla biblioteca civica, dove però non cerca notizie su Bazlen, bensì su persone che l'hanno conosciuto. Decide di andarne a trovare una, che vive nel comprensorio di san Giovanni, un tempo sede del reparto lungodegenti, dove è ricoverata una delle protagoniste della cultura triestina.
Si tratta evidentemente di Anita Pittoni, che rievoca per lui gli incontri letterari a casa sua, con Giotti, lettore delle pagine dei classici d'ogni tempo e luogo, e gli altri occupati a conversare bevendo il tè. Il protagonista nei suoi giri rifà più volte il tragitto tra il ghetto e il municipio, e dunque entra nella grande piazza, che descrive come perfettamente nordica, simile a quella di Salisburgo, che però sul quarto lato ha il teatro, non il mare. Preda di queste suggestioni, tornando per l'ennesima volta in stazione continua a "vedere" l'Austria, pur con qualche incertezza, nel tram bianco e azzurro che parte da una pensilina racchiusa da aiuole, come in un plastico Märklin. Altre volte, invece, dalla stazione si reca in un caffè dove incontra persone che infine gli fanno capire come quel personaggio così prodigo di consigli agli altri, era esigente con sé al punto da non rischiare di pubblicare qualcosa che non fosse sufficientemente nuova o originale. Ma a guidarlo verso l'epilogo è la città stessa, anzi il suo porto, che scopre camminando lungo le banchine pulite, lucide come le bitte, e scrutando i moli, ripuliti dalle alghe. Il fatto che nulla sia in abbandono, nemmeno i solchi delle rotaie o i bracci delle gru ripiegati come uccelli, gli fa capire che forse quell'immagine è artefatta, come se la navigazione fosse stata asportata dalla città con un colpo secco, e ne sia rimasto l'incavo, preciso, rifilato.
Salendo verso il colle, probabilmente di S. Vito, nota che ad ogni angolo la visuale si ribalta e, attraversando zone nuove, margini di una periferia che non immaginava esistesse, con palazzoni ferroviari e panni stesi, pensa all'Est Europa. Ed è così che comincia a delineare la peculiarità di una città di frontiera, considerando verso la Jugoslavia tutto ciò che è a destra della stazione, verso l'Italia tutto quanto è a sinistra. In questa nuova geografia fa gli ultimi incontri con due donne, di cui una è Gerti Frankl Tolazzi, autrice dello scatto che ritrae le gambe della misteriosa Dora Markus, una foto che Bazlen inviò a Montale chiedendogli di farne una poesia. Gerti gli porge foto di personaggi, alcuni morti e altri ancora vivi, ruotanti intorno all’uomo che non scriveva, pur avendo una vivida coscienza letteraria: è certa che sua massima aspirazione fosse stata proprio quella di “far vivere” gli amici attraverso la cultura stessa.
Prima di partire per Wimbledon, dove incontrerà Ljuba Blumenthal, altra musa montaliana, torna un’ultima volta a Trieste, d'estate, scoprendo una città che non immaginava, quasi mediterranea, con i bagnanti e le vele dei windsurf. Un'altra faccia, dunque di una città imprendibile, come la conoscenza. Ma quando, col treno, ripassa nello stesso punto stretto tra le rocce e il mare, una sciabolata di luce abbaglia il finestrino e per un istante disegna a terra i contorni delle cose. Questa volta "vede" il faro bianco e monumentale e immagina la traiettoria di quel lampo. Lo scrittore sa ora di dover fare come il navigante, che segue il fascio di luce calcolando continuamente la distanza; è un buon modo quello di avvicinarsi alle cose misurando sempre quanto se ne è lontani. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








