«Il male può sedurre chi cerca un rimedio alle sue insicurezze»
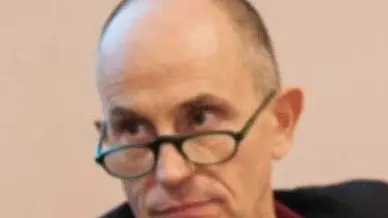
l’intervista
A.R. Avanguardia Rivoluzionaria. Questa l’associazione clandestina nazifascista disarticolata dalla Procura di Milano. A idearla quattro studenti, due dei quali iscritti all’Università di Trieste. Insomma pare che guerre e olocausti non siano stati sufficienti a sradicare razzismo e intolleranza. I ragazzi si ispiravano a gruppi suprematisti americani con l’“ideale” di perseguire un nuovo ordine morale alimentato da odio etnico e violenza. Ma qual è il motivo per cui, nel terzo millennio, c’è ancora tanta fascinazione per il male? «Semplicemente perché è di per sé seducente, spesso coincide con una violazione delle regole che restituisce un senso di potenza». A parlare è Fabio Polidori, docente di Filosofia teoretica all’Università di Trieste ed autore di diversi testi filosofici.
I giovani ancora sedotti da ideologie estreme. Qual è l’elemento di attrattiva?
«Anzitutto proprio il loro carattere estremo. Condotte di vita a tinte sfumate o moderate non sono destinate a esercitare grande fascino in persone molto giovani e perciò inclini all’esuberanza. Questo però vale solo in generale, perché iniziative e derive di carattere nazifascista implicano distorsioni profonde».
Come l’insicurezza?
«Molto probabilmente conflittualità esasperate e mal governate nell’età della formazione possono condurre a sentimenti di insicurezza, compensati dall’adesione a ideologie nette e illusoriamente vincenti, prive di complessità, che ripartiscono il mondo in superiori e inferiori. E alla volontà di affermazione si affianca un senso di appartenenza molto forte, perché condiviso da pochi che si ritengono eletti».
Ma è una questione di formazione o di epoca?
«Giocano entrambi i fattori. Sappiamo che il primo fattore, quello della formazione umanistica, è oggi profondamente in crisi, una crisi che, in ambito scolare, viene nascosta sotto cifre che manifestano preoccupazione principalmente per l’impiego lavorativo. È uno dei grandi problemi di quest’epoca».
Come mai?
«Per un verso è un’epoca estremamente prodiga di agevolazioni e attenzioni nei confronti dei più giovani ma insensibile e pigra nei confronti di quegli elementi formativi indispensabili che costituiscono ostacolo a una volontà intesa dagli adolescenti come assenza di limiti. Non sto parlando di repressione ma di confronto, del carattere formativo insito in una discussione in cui le proprie idee e i propri punti di vista si cimentano con quelli altrui, genitori, insegnanti, coetanei ecc. La progressiva perdita di rilevanza di tutta la formazione umanistica è in tal senso senz’altro una causa».
È comunque innegabile, al di là di vere e proprie associazioni razziste clandestine, che sia difficile anche per l’uomo comune avere a che fare con la “diversità”.
«L’uomo comune – e con ciò dobbiamo intendere ciascuno di noi nella nostra dimensione quotidiana – è naturalmente incline a tutelare il “proprio” e a proteggersi dall’ipotetico pericolo rappresentato dal “diverso”. Poi però, quando il “diverso” diventa “inferiore”, la cosa cambia radicalmente aspetto. Viene meno lo sguardo critico grazie al quale ciascuno dovrebbe intendere il “diverso” attraverso la sua complessità, riconoscendovi anche tratti di superiorità rispetto a noi, istanze che ci mettono in gioco, che ci migliorano».
Tra l’altro i giovani inquisiti sono studenti universitari. Spesso si imputa all’ignoranza l’affezione a certi disvalori.
«L’ignoranza è un ingrediente importante di alcuni disvalori. Ma va detto che ci sono saperi e saperi. E non sempre un sapere impiegabile nel cosiddetto mondo del lavoro è un sapere critico. Anzi».—
Riproduzione riservata © Il Piccolo








