La ricerca fa ridere se la fusione fredda crea l’uovo di gallina
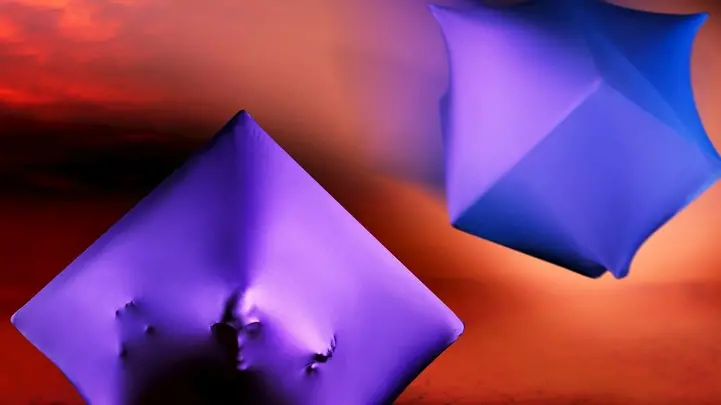
di PIETRO SPIRITO
Ci sono i partigiani degli Ufo, naturalmente. A cominciare dai due burloni David Chorley e Doug Bower, che hanno ingannato il mondo intero con i loro cerchi di grano. E poi c’è Dolores Krieger, esegeta internazionale dei benefici del tocco terapeutico, una tecnica che permette agli infermieri di manipolare i campi energetici dei pazienti sofferenti evitando qualunque contatto fisico. E che dire di Corentin Louis Kervran, ammiratore dell’alchimia, che dopo attenti studi ed esperimenti è «giunto alla conclusione che il calcio dei gusci delle uova di gallina è stato creato da un processo di fusione fredda». Ma ci sono anche due italiani, Marina De Tommaso e Paolo Livrea, della facoltà di Neurologia e psichiatria dell’Università di Bari, che «hanno misurato il dolore provato da persone che guardano un brutto dipinto rispetto a quelle che ammirano una bella tela, quando si invia sulla loro mano lo stimolo di un potente raggio laser». Sono tutti scienziati, o pseudo scienziati, o veri e propri ciarlatani, accomunati dall’aver ricevuto il premio Nobel. Non, però, quello conferito a Stoccolma, bensì l’anti-Nobel consegnato ogni anno dall’Università di Harvard alle dieci scoperte scientifiche più stravaganti e inutili. È l’Ig Nobel, riconoscimento assegnato con l’intento programmatico di «far prima ridere e poi riflettere». Nel corso di una sontuosa cerimonia, un vero e proprio galà cui partecipano con gioia anche autentici premi Nobel, gli improbabili scienziati - quelli che accettano l’invito - sono chiamati a esporre in ventiquattro secondi esatti la loro ricerca attraverso una “descrizione tecnica completa”, seguita da un riassunto in sette parole comprensibile a tutti, con risultati esilaranti che scatenano fra il pubblico un entusiasmo da stadio. L’Ig Nobel va avanti dal 1991 per volontà di Marc Abrahams, matematico e informatico, a sua volta un burlone patentato, inventore negli anni Ottanta dei “Simulatori di saggezza”, strumento informatico che permette di fare la scelta giusta in ogni circostanza, antenato della formazione interattiva. Abrahams, che «ha il dono di presentare tutte le scoperte, che siano pazzoidi o serie, in modo ugualmente esilarante», in tutti questi anni con i suoi Ig Nobel è riuscito quantomeno a dimostrare che «nonostante a volte divaghi, nonostante venga praticata da esseri umani, dunque necessariamente imperfetti - compresi vecchi rimbambiti, ambiziosi carrieristi, fanatici e, perché no, imbroglioni -, la scienza sa essere sottile, affascinante e grandiosa».
Ce lo raccontano. le fisiche Aleksandra Kroh e Madeleine Veyssié nel libro “14 scoperte scientifiche che non sono servite a niente” (Bompiani, pagg. 380, Euro 13,00), dall’onesto sottotitolo “Benché questo sia tutto da dimostrare”. Armante di santa pazienza e scientifica competenza, Kroh e Veyssié hanno spulciato gli annali dell’Ig Nobel cogliendo fior da fiore, fino a mettere insieme un’antologia di storie spassosissime, dando però al lettore le informazioni scientifiche necessarie perché possa farsi una propria opinione sulle scoperte proposte.
Il repertorio di base era enorme, con autentiche genialità come «l’inventore di un metodo per fermare il singhiozzo persistente tramite massaggio rettale», o la presentazione del “dissuasore per adolescenti”, un dispositivo elettromeccanico «in grado di produrre suoni ad alta frequenza, molto sgradevoli, udibili esclusivamente dai più giovani». Ma le due autrici hanno prediletto le ricerche più scientificamente sostenibili, per così dire, quelle dove il confine fra il colpo di genio e la follia si fa molto sottile. Come nel caso di Jacques Benveniste, medico e biologo, ricercatore affermato, direttore di un grande laboratorio specializzato in immunologia, che si è aggiudicato non uno bensì due Ig Nobel, sia per i suoi medicinali omeopatici, sia per la teoria sulla memoria dell’acqua, in virtù della quale «l’acqua che non contiene più alcuna molecola attiva potrebbe restare essa stessa attiva, come se conservasse il ricordo delle sostanze con cui è stata in contatto». Teoria assai suggestiva, ma le molecole fantasma di Benveniste finiranno per sparire nel nulla dopo anni di lotte per affermare la loro esistenza.
Risate a parte il loro libro, dicono le autrici, affronta «con grande modestia un problema dalla massima importanza: la percezione della scienza nella società contemporanea, tempo in cui tutti noi beneficiamo «dei vantaggi che essa porta nel quotidiano», ma tanti, forse troppi «la ritengono sclerotizzata, visceralmente attaccata ai propri dogmi e refrattaria alle grandi idee innovatrici», cedendo piuttosto alle lusinghe di «superstizioni medioevali, rivelazioni incredibili o alla spiritualità New Age».
@p_spirito
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








