Lo scienziato: «Premio da un milione di dollari? Non ci penso»
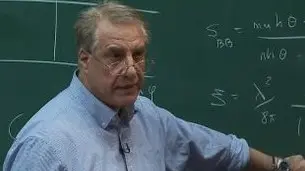
trieste
Giuseppe Mussardo, fisico teorico della Sissa, è uno scienziato dal multiforme ingegno, appassionato di storia della scienza, di letteratura, di cinema. Pugliese di Lecce, laureato a Pisa, dottorato alla Sissa, dove è professore ordinario e ha fondato il gruppo di fisica statistica.
Accanto a un’intensa attività scientifica e didattica, negli ultimi quindici anni Mussardo ha realizzato cinque film-documentari su altrettante grandi figure della fisica e della matematica: Ludwig Boltzmann e Subrahmanyan Chandrasekhar (per la regia di Enrico Agapito) e Abdus Salam, Bruno Pontecorvo e Évariste Galois (regista Diego Cenetiempo). Nel 2019 ha pubblicato con la casa editrice triestina Scienza Express “L’infinita scienza di Leopardi” (scritto assieme a Gaspare Polizzi); l’anno scorso, per le Edizioni Dedalo, “L’alfabeto della scienza”, ventisei storie biografiche di scienziati e scienziate; e quest’anno, sempre per i tipi di Dedalo, “Tra Cielo e Terra. In viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo” (scritto a quattro mani ancora con Polizzi).
Allora, professor Mussardo: in questo vostro lavoro sulla congettura di Riemann sembra quasi che vi sia stata un’inversione di ruoli tra fisica e matematica.
«Be’, in un certo senso è proprio così. In genere tra fisica e matematica la differenza è netta: la fisica è interessata alle teorie, la matematica è interessata ai teoremi. Questa volta, invece, abbiamo impiegato i concetti di probabilità della fisica per mostrare che la congettura di Riemann è corretta. Ma la dimostrazione rigorosa della congettura resta ovviamente compito dei matematici».
Lei e il suo collega LeClair usate il termine “svelata”…
«Infatti. Nel senso che abbiamo potuto chiarire che la congettura è vera con una precisione del 99,9 per cento di probabilità. Che è un valore di confidenza – per dire – paragonabile a quello che nel 2012 ha consentito ai fisici del Cern di affermare di aver scoperto il bosone di Higgs. Insomma: abbiamo affrontato un problema matematico usando gli strumenti della fisica e mettendo così in evidenza l’unità del sapere scientifico».
Voi parlate di una ricerca con tre anni di analisi dei dati…
«Sì, è stato un autentico tour de force, specie nella parte finale del lavoro. Il mio Mac di alta precisione ha masticato milioni di dati».
Nel 2000 il Clay Mathematics Institute di Cambridge, Massachusetts, aveva inserito la congettura di Riemann tra i sette cosiddetti “Millennium Problems” mettendo in palio un premio da un milione di dollari per chi risolverà ciascuno di questi problemi matematici epocali. Per non parlare della prestigiosissima Medaglia Fields… Lei non ci ha fatto un pensierino?
«Per carità, non ci penso nemmeno! Io sono un fisico, ma sono contento di aver capito un problema di matematica. Tutto qui». —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








