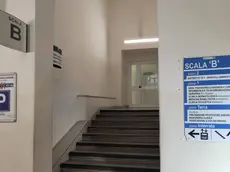Giulia ci parla: la salute mentale è civiltà condivisa
Ogni famiglia che chiede sostegno, e non lo trova, è parte di questa ferita sociale: tradire l’eredità di Basaglia significa tradire un intero modello di convivenza

I fiori vicino al dirupo del Monte Grisa. Le parole e la dignità di due genitori. La lettera d’amore di un padre, la denuncia lucida di una madre. Le foto bellissime dei tempi sereni. Giulia Bonin con la sua storia dolorosa dissemina di simboli significativi la nostra estate. Abbiamo raccontato la sua scomparsa, l’ansia, le ricerche e le paure, il ritrovamento straziante dell’11 agosto, la pena e la malinconia.
Si è alzata la voce diretta e sincera di una famiglia che piange e pone domande. Ci hanno ricordato che per assistere questa ragazza di 25 anni, seguita dal Centro di Salute Mentale, erano decollate molte richieste di aiuto, inequivocabili, autentiche. Tanti, troppi contatti e tanti, troppi silenzi o comunque ritardi, rimandi, dilazioni, burocrazie, squilli di telefono a vuoto. Avevano chiesto persino il TSO, senza ottenerlo: è impossibile immaginare completamente la disperazione di una famiglia che arriva a questo.
Giulia è morta ma ci sta parlando. E non ci parla solo di se stessa.
Gli articoli del Piccolo, i ricordi degli amici, l’inchiesta per omicidio colposo, il funerale. L’assessore regionale Riccardi ha chiesto al direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, un rapporto sul caso e accertamenti sul Centro di Salute Mentale di via Gambini. È utile, è necessario. Ma l’ultimo affronto che potremmo fare a Giulia è quello di considerarla un caso singolo, raro, decontestualizzato.
La sua storia è una luce accecante che si accende in un buio. Si accende nel modo più triste, quello irrimediabile. Ma illumina. E prima che si spenga, e prima che ne arrivi un’altra, di tragedie, possiamo – forse dobbiamo – esercitare il diritto e il dovere della riflessione. Proviamo a ricordare Giulia come la ragazza che ci aprì gli occhi.
***
E allora parliamo con lei e con noi stessi. Parliamo di un gigante come Franco Basaglia, della sua visione di svolta, costruita e partita proprio dai nostri territori. Ma parliamo anche dell’applicazione reale di quel pensiero.
Il sistema psichiatrico nazionale meriterebbe un approfondimento serio a ogni livello (dalla politica alla stampa); ma non possiamo sottrarci a un esame onesto, specifico, del sistema psichiatrico triestino, che mostra punti ciechi, incompletezze, ferite aperte. Deve essere rivisto, rinforzato nelle sue coordinate fondanti, l’ascissa e l’ordinata di ogni intervento: le risorse investite e le persone impiegate. Servono spazi, idee, presenza.
Troppi nuclei familiari combattono battaglie senza alleati, con danni collaterali di inaccettabile entità. Chi amministra il bene pubblico ha fatto una riflessione seria su come aiutarli? In troppe camere da letto, in troppi corridoi degli appartamenti ci sono persone che affrontano i loro demoni. Vicine a loro, nelle stesse case, ci sono altre persone che convivono con drammi, pericoli, con tramonti psichici e angosce incalcolabili. Suicidi, annichilimenti, depressioni, stress senza pari, rotture nelle relazioni esistenziali, crisi economiche dovute a un impegno ingestibile. E i farmaci come risposta. Ma i farmaci in una casa come sono governati, dispensati, controllati?
Se ci troviamo di fronte a una debolezza cronicizzata, a una inefficacia realizzativa rispetto a una straordinaria idea di fondo, l’attenzione della comunità si deve alzare una volta per tutte. E ogni sensore deve attivarsi. Ci sono tre argomenti che non ci possiamo permettere di trascurare.
Il primo è la condizione di solitudine drammatica – forse bisognerebbe parlare di isolamento – alla quale sono state relegate le famiglie di chi soffre di malattie mentali.
Il secondo è l’uso talvolta disinvolto, semplificato ed esclusivo della farmacologia.
Il terzo è una dialettica politica che non ci meritiamo. Fatta di postulati e di posizioni contrapposte. Le impostazioni di Basaglia onestamente non si possono confutare, salvo tornare indietro, tornare a un’Italia cupa. Ma riscontrano da una parte un mero favore dogmatico, senza cura esecutiva, e dall’altra una grave erosione dei necessari fondi pubblici e anche una serie di posizioni ideologiche avverse a un mondo giudicato “di sinistra”, così, tout-court, e smantellato nelle fondamenta del sostegno economico ai progetti, senza peraltro fornire uno straccio di soluzione alternativa. Senza applicazione, e senza sostegno economico, Basaglia è tradito e mortificato.
E quindi che cosa si dovrebbe fare?
Dovremmo parlare con chi vive sulla propria pelle il disagio incommensurabile di ritrovarsi abbandonati. Lasciamo che, se vogliono, ci raccontino le sofferenze provate, nel nervo scoperto di un sistema sociale che non li supporta a sufficienza.
Dovremmo anche ascoltare i medici e gli altri operatori della sanità, in tutti i loro versanti: i basagliani più convinti, gli scettici, i portatori di distinguo e gli abitanti delle terre di mezzo.
Dovremmo indagare su come la ricerca e la scienza medica stiano cercando nuove risposte farmacologiche e non solo.
Infine dovremmo sfidare la politica regionale (e anche quella comunale), di governo e di opposizione, a sostenere la comunicazione di questo tema sensibile e a spiegarci che cosa si potrebbe fare. E perché non lo si fa.
Trieste è stata per decenni un’eccellenza internazionale. Oggi invece questa vicenda tragica – e con essa tante altre esperienze e testimonianze – ci racconta qualcosa. Giulia ci dice che le famiglie sono troppo abbandonate nella gestione, delicatissima e tensiva, di una persona in difficoltà dal punto di vista della salute mentale. Davvero si è pensato che chiudere i manicomi bastasse? E dov’è finito l’altro pezzo, decisivo?
Nel pensiero di Basaglia la chiusura di certe strutture da incubo, ermetiche, respingenti, isolazioniste, è il basamento portante di un sistema che poi affianca le famiglie e inserisce la persona nelle dinamiche delle relazioni sociali, del lavoro e dell’esistenza. Ma, per esempio, il fatto che un centro di salute mentale a Trieste venga chiuso la sera – i pazienti “tradotti” in un altro complesso, e poi ripresi e ricondotti in via Gambini una volta trascorsa la notte – è devastante per le famiglie e per i pazienti. Lo è anche per i professionisti e gli operatori.
In una città come Trieste il Centro di via Gambini deve essere aperto ininterrottamente, 24 su 24 e sette su sette. Rimandare questa operazione è un’indifferenza che possiamo permetterci? No. La malattia non è di destra né di sinistra, chiedere accesso a via Gambini in ogni orario non è una questione ideologica ma di civiltà. E riguarda chiunque. Questo tipo di sanità deve essere anche sartoriale, tagliata sul quadro clinico e psicologico della persona in cura. E non c’è videochiamata che tenga: occorrono presenza e contatto, competenza, chilometraggio di esperienza nel gestire le questioni esplosive, alta formazione nell’approccio tecnico, umanitario e culturale.
***
Ridurre la narrazione di questo dramma sociale a uno slogan semplificatorio – basagliani contro anti-basagliani, per esempio – non va bene e non fa onore a nessuno. Questo non è un derby di calcio. Esistono innumerevoli sfumature e articolazioni che devono spingerci a maneggiare con cura; vale a dire a esaminare questo tema con il più profondo rispetto e con una grande apertura.
La salute è un diritto costituzionale e la salute mentale ne è parte integrante. Non si tratta di gestirla con una cornice di finalità contabili. La buona amministrazione qui non si misura con i numeri di bilancio ma con le condizioni del capitale umano. Restituire risorse e umanità a questo servizio è un dovere verso il prossimo. Non esiste un risparmio, in questo campo, che possa indurre all’applauso.
Riproduzione riservata © Il Piccolo