Trieste Next, tutti in fila per il Nobel Kobilka
Teatro Verdi pieno e file all’esterno per l’evento con il chimico Kobilka. Lezione fra linguaggio delle cellule e strada percorsa fino al premio del 2012

Un premio Nobel calca il palco del teatro lirico Verdi di Trieste, che registra il tutto esaurito, con lunghe file all’ingresso. Ci sono 1.200 cittadini – fra cui molti ragazzi – che fissano lo sguardo sul professor Brian Kobilka, premio Nobel per la Chimica 2012, per ascoltare come funziona il linguaggio invisibile con cui le cellule si parlano.
È la magia di Trieste Next, il festival che riesce a coinvolgere non solo scienziati e ricercatori ma anche giovani studenti e cittadini comuni davanti a slide che mostrano le complesse strutture di proteine e recettori.
Trieste Next è un progetto Nord Est Multimedia. È co-promosso dalla Regione Fvg e promosso anche da Comune, Università, Area Science Park, Ogs, Sissa; curato da Post Eventi, ha Generali come main partner.
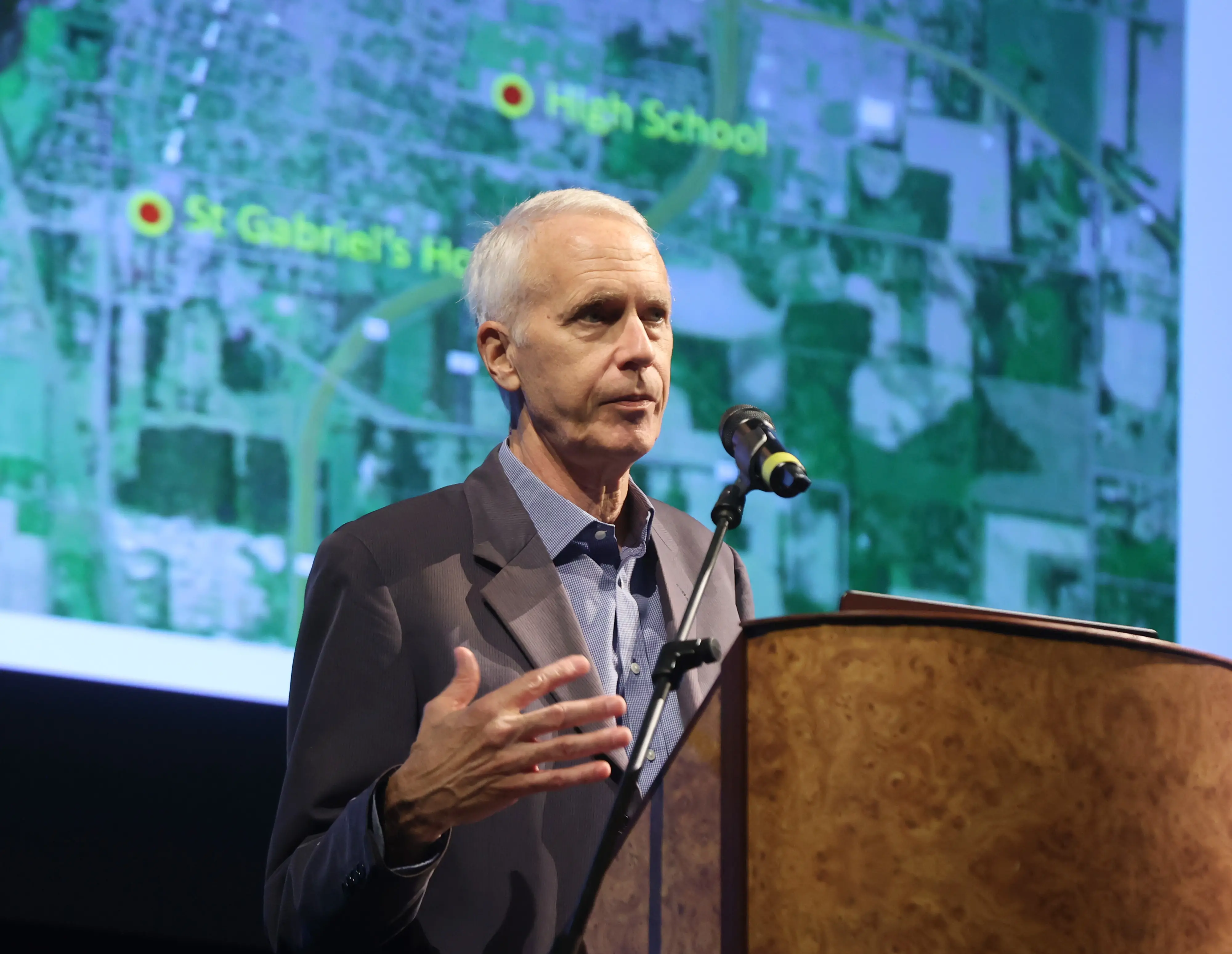
Prima del via alla conferenza, su invito di Paolo Fornasiero, prorettore della Ricerca dell’Università di Trieste, si è osservato un minuto di silenzio per Marta Gianelli, la giovane ricercatrice di Chimica che ha perso la vita in un tragico incidente, investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Il caso governa le nostre vite, questa è quella che sembra essere la filosofia di Brian Kobilka nella prima parte della sua lezione. «Sono stato molto fortunato», ripete molte volte, e quasi altrettante afferma: «Ho avuto molti bravissimi collaboratori». Quando inizia a parlare la sua emozione è palpabile. Avere un premio Nobel non mette al riparo dall’essere intimiditi da un teatro pieno che pende dalle tue labbra.
Incomincia raccontando del piccolo villaggio in Minnesota dove è nato e cresciuto, una cittadina di 7.500 anime vicino al fiume Mississippi. «Mio padre aveva una panetteria, il primo lavoro che ho avuto è stato tagliare il pane», dice.

Ciò che l’ha portato al premio Nobel è stato ammirare molto i papà di tre suoi amici che facevano i medici, così ha voluto diventare un medico a sua volta: «Aiutavano le persone e avevano delle belle case». Così è andato a Duluth dove c’è l’Università del Minnesota, «il posto più freddo dello Stato», e lì ha incontrato sua moglie. Poi ha continuato a studiare a Yale, poi St Louis, alla fine Stanford.
Tra trasferimenti da un capo all’altro degli Stati Uniti, ha scelto di diventare cardiologo, e ha iniziato a fare ricerca quasi per caso: gli sembrava un modo per stare più vicino alla sua giovane famiglia, gli erano nati due bambini. Poi arriva a Stanford e inizia a lavorare nel laboratorio di Robert Lefkowitz dove si lavora sui recettori accoppiati alla proteina G (Gpcr).

Proprio lo studio di questi recettori gli varrà il premio Nobel. E rimane un tema che gli interessa ancora oggi: il suo sogno, confida quando gli viene chiesto durante l’intervista con Gabriele Beccaria, responsabile di Tuttoscienze de La Stampa, è quello di riuscire a capire meglio come funzionano così da permettere di creare dei farmaci «più selettivi, più sicuri e più funzionali». D’altro canto, spiega, «un terzo dei farmaci sul mercato ha come target i Gpcr». Un sogno che da un lato tradisce il suo passato da medico e l’interesse che va oltre alla pura scienza di base, dall’altro la passione per risolvere un problema da tutta la sua vita.
Insomma, come ripete è convinto di aver vinto il Nobel perché si è trovato «nel posto giusto al momento giusto, e ha conosciuto le persone giuste». Ma è chiaro che l’impegno e la risolutezza sono quello che gli ha permesso di arrivare dove è arrivato. Anche di questo c’è bisogno per arrivare al Nobel. Lui stesso racconta che per le scoperte che gli sono valse il premio ci sono stati «molti esperimenti che non sono andati a buon fine, e da questi abbiamo imparato moltissimo».
Quando Beccaria gli chiede se è preoccupato per quanto sta accadendo alla ricerca scientifica negli Stati Uniti, risponde di non essere «molto preoccupato per il mio laboratorio, ma sono preoccupato per i miei studenti e i miei postdoc, che si troveranno a entrare in un mercato del lavoro molto più precario: anche perché l’attuale amministrazione non supporta la scienza». Dice anche di essere preoccupato «per come quanto sta succedendo può avere un impatto sulla possibilità di ricevere cure da parte dei più poveri», nonché del fatto che «la retorica antivaccinista sta già creando problemi ai bambini in alcuni Stati: è tornato il morbillo che non vedevamo da moltissimo tempo». Insomma l’amministrazione Trump preoccupa anche un premio Nobel.—
Riproduzione riservata © Il Piccolo









