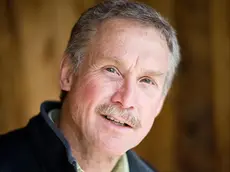Pasinelli a Trieste Next: «Vogliamo giovani matti per la scienza: così si stimola il pensiero critico»
Francesca Pasinelli, una vita passata tra le fondazioni Telethon e Diasorin: «Per l’innovazione occorrono più cultura d’impresa e attitudine al rischio»

Non solo futuri scienziati, ma cittadini consapevoli. È questa la scommessa di Francesca Pasinelli, che dopo aver trasformato Telethon in un modello di eccellenza nella ricerca sulle malattie genetiche, oggi alla guida di Fondazione Diasorin punta sulla formazione scientifica nelle scuole.
«Vogliamo far diventare i giovani matti per la scienza», dice con un sorriso per spiegare il perché del nome “Mad for Science”, scelto per il concorso che ogni anno coinvolge centinaia di istituti italiani. Un concorso dall’approccio innovativo: invece di imparare la scienza sui libri, i ragazzi la sperimentano nei laboratori, sviluppando quello che lei chiama «pensiero critico».
In un’epoca di fake news e disinformazione, è una battaglia culturale decisiva. Venerdì a Trieste Next nel panel di apertura dedicato alla cultura dell’innovazione, Pasinelli porterà l’esperienza di chi ha visto crescere talenti: l’Italia deve creare luoghi così attrattivi da competere nel «campionato mondiale» della ricerca, non limitarsi a coltivare eccellenze regionali.
Da Telethon a Fondazione Diasorin: come si applica il rigore scientifico in contesti così diversi?
«Sono due fondazioni con personalità diverse, ma che si incontrano sul tema scientifico. Dal punto di vista procedurale, il modello è simile: come a Telethon invitiamo gli scienziati a presentare progetti di ricerca, così Diasorin chiede alle scuole di preparare progetti quinquennali. I ragazzi devono scrivere progetti esattamente come fanno gli scienziati, poi vengono messi in gara, passando attraverso una valutazione stringente con il parere di esperti. È una forma di peer review che punta all’eccellenza».
L’intelligenza artificiale sta cambiando anche i processi di valutazione. Servono nuovi paradigmi?
«L’utilizzo dell’Ia nei processi di valutazione è sicuramente molto utile. Per anni, la ricerca dei revisori esperti per i progetti Telethon avveniva manualmente, poteva richiedere settimane. Ora i sistemi di intelligenza artificiale permettono di individuare rapidamente una rosa di possibili revisori compatibili con i progetti. È un’accelerazione dei processi che migliorerà molto questi percorsi, ma avrà sempre bisogno di un vaglio critico umano».
Come dovrebbe essere il ricercatore del futuro?
«Molto curioso, aperto alla novità, sgombro da pregiudizi. Disponibile alla fatica e resistente ai fallimenti, perché il percorso della ricerca è ricco di strade che si rivelano diverse dalle aspettative. Rispetto al passato, è ancor più importante che sappia lavorare in team: la ricerca è sempre più interdisciplinare. Deve sapere unire molti puntini, rintracciare le competenze giuste e farsi aiutare da chi le possiede».
Mad for Science non forma solo scienziati, ma cittadini capaci di pensiero critico…
«Questa è la nostra speranza. Non tutti questi ragazzi si iscriveranno a facoltà scientifiche, ed è giusto così. Ma ci auguriamo che tutti imparino cos’è il metodo scientifico e capiscano le logiche alla base del pensiero scientifico. Il pensiero antiscientifico non le conosce e si porta dietro pericoli enormi: ragionamenti acritici, miracolistici, che possono provocare grossi danni alla salute pubblica. Vogliamo cittadini scientificamente preparati, che conoscono come la scienza continua a interrogarsi e validarsi. Mai come in questo periodo ce n’è bisogno».
Le fondazioni private rischiano di orientare ricerca e formazione verso interessi specifici?
«Sono una risorsa preziosa in quanto sussidiaria al sistema pubblico. Agiamo in modo complementare: investiamo nei progetti di scienziati dipendenti dell’università, diamo denaro ai laboratori delle scuole. Siamo la benzina di una macchina che deve essere tenuta in perfette condizioni dal settore pubblico».
Qual è il vero ostacolo culturale che frena l’innovazione in Italia?
«Servono strutture evolute di trasferimento tecnologico nelle università, gruppi con competenze eterogenee che lavorino in prossimità con gli scienziati. Lo scienziato genera idee ma non ha la competenza né la vocazione per trasformarle in prodotto. Poi ci sono problemi normativi: le regole della pubblica amministrazione comportano lungaggini che disincentivano gli investitori. E ci manca cultura d’impresa e abitudine al rischio: questo frena l’innovazione».
Cosa serve a un territorio per diventare competitivo nella ricerca?
«Nella scienza esiste un solo campionato, ed è il mondiale. Bisogna essere competitivi a livello internazionale, individuare nicchie di assoluto valore, avere la forza di andare a cercare talenti anche dall’estero. L’attrattività si aumenta creando luoghi dove un ricercatore può trovare i migliori colleghi, le migliori attrezzature, i migliori maestri. Pensi al design: il nostro paese attrae talenti da tutto il mondo perché qui si realizza quello che altrove non sarebbe possibile. A questo dobbiamo ambire anche nella ricerca». —
Riproduzione riservata © Il Piccolo